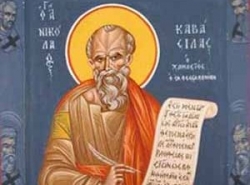Formazione Religiosa
Visualizza articoli per tag: Patrologia
Tertulliano (Lorenzo Dattrino)
TERTULLIANO
di Lorenzo Dattrino

Se si eccettua l’Octavius di Minucio Felice, la cui data è incerta, la letteratura cristiana fa la sua prima comparsa nel 197 con le opere di Tertulliano. (1)
Novaziano (Lorenzo Dattrino)
NOVAZIANO
di Lorenzo Dattrino

Il suo nome non appartiene solo alla Patrologia e alla storia della chiesa. Fu il primo grande scrittore in lingua latina. Sono incerti il luogo e la data della sua nascita: è opinione ormai accettabile che egli sia nato a Roma intorno all’anno 200. La sua apparizione, però, molto tarda, s’aggira verso il 250, nella chiesa di Roma, prima come catecumeno, poi, per il sopraggiungere d’una grave malattia, in grado di ricevere il battesimo. È da questi primi eventi, pur così modesti, che ebbe inizio la sua ascesa, legata ad avvenimenti di rara gravità specialmente per la chiesa di Roma, come conseguenza della persecuzione di Decio.
Novaziano, ad altissime doti d’ingegno e di cultura, univa purtroppo non poca ambizione, anche se unita a molta austerità di vita e a poca socievolezza. Godette comunque di grande stima nella comunità romana, e venne ordinato presbitero, con probabilità, dallo stesso papa san Fabiano. Infuriava allora la persecuzione di Decio, durante la quale trovò la morte papa Fabiano. La chiesa di Roma rimase per alcun tempo senza pontefice: quell’assenza durò ben quattordici mesi. La comunità cristiana venne allora governata dal Presbyterium, un collegio, di cui faceva parte, non certo secondaria, lo stesso Novaziano. Fu in quel tempo che sorse a Roma, e anche a Cartagine, la cosiddetta questione dei lapsi (i caduti), di coloro cioè che si erano resi colpevoli d’aver prestato culto agli dei, culto imposto dall’imperatore: in seguito essi, dichiaratisi pentiti, chiedevano il pubblico perdono. TI nuovo papa, Cornelio, si mostrò incline a concederlo (251). Novaziano si oppose, fino ad accusare il pontefice di lassismo. Ne nacque presto uno scisma molto violento. Novaziano si abbandonò a una propaganda attivissima, al punto di provocare l’adesione di non poche chiese dell’Oriente. Papa Cornelio, frattanto, riuniva nell’autunno del 251 un solenne concilio romano che deliberò la scomunica di Novaziano. Sulle vicende degli ultimi anni e della morte di lui mancano notizie sicure.
E ora, al di fuori delle sue vicende biografiche e, in particolare, intorno alla questione dei lapsi, che meriterebbe una trattazione a parte, esaminiamo le opere di Novaziano. Sono certamente autentici due trattati, il De Trinitate, composto probabilmente prima del 250, e il De cibis iudaicis, scritto dopo lo scisma; altri due trattati, De Spectaculis e De bono pudicitiae, e, infine, due lettere dirette a S. Cipriano.
Ci interessa in particolare il De Trinitate. Più che un trattato dogmatico vero e proprio, l’opera espone le tre verità principali del Simbolo, la regola di verità (regula veritatis). Si articola in tre parti: la fede nel Padre (cc. 1-8); la fede nel Figlio, del quale è ugualmente affermata la divinità e l’umanità (cc. 9-28), e nello Spirito Santo, di cui rapidamente sono esposti gli attributi (c. 29). Gli ultimi due capitoli (cc. 29-30) dichiarano che la distinzione delle Persone non compromette l’unità divina. Tuttavia, mentre appare sicura la sua dottrina nei confronti del Padre, da meno vi appare quella intorno a Cristo. Pur essendo da lui dichiarato Figlio di Dio, l’autore non lo rende esente da certo quale subordinazionismo.
Per l’approfondimento
Edizioni
PL 3,911-1000; 4,810-860 (tra le opere di Cipriano); CSEL 3,3; CCL 4.
Traduzioni
Studi
V. Loi, Novaziano: La Trinità, Torino 1975
V. Loi, La latinità cristiana nel «De Trinitate» di Novaziano, in «Rivista di cultura classica e medioevale» 13 (1971), 1-42 e 136-172; M. Simonetti, Alcune osservazioni sul «De Trinitate» di Novaziano, in «Studi in onore di A. Monteverdi», Il, Modena 1959, pp. 771-783.Ippolito di Roma (Lorenzo Dattrino)
IPPOLITO DI ROMA
di Lorenzo Dattrino

Sembra fosse originario della Grecia. A Roma egli divenne prete durante il pontificato di Zefirino (199-217). Alla morte di Zefirino divenne papa Callisto (217-222). Ippolito si pose in una posizione di contrasto, soprattutto perché giudicava troppo indulgente la condotta disciplinare del vescovo di Roma nei riguardi della penitenza e del matrimonio. Ormai è opinione comune che Ippolito spingesse la sua opposizione fino alla creazione di uno scisma che durò fino al 235: fu il primo antipapa della storia. L’assunzione al trono imperiale di Massimino il Trace, nemico dei cristiani, portò all’arresto contemporaneo di Ippolito, riconciliatosi con la chiesa, e del nuovo vescovo di Roma, Ponziano. Furono deportati in Sardegna, dove ambedue morirono martiri della fede. Il papa Fabiano, successo a Ponziano, fece portare a Roma i loro corpi. Nel 1551, nella zona dell’antico cimitero di Via Tiburtina, si scoprì una statua che venne dai più riconosciuta per quella di Ippolito: ora essa è conservata nell’atrio della Biblioteca Vaticana. Su uno degli stipiti, lo stesso marmo porta pure inciso il catalogo delle opere che si riferiscono al periodo degli scritti di Ippolito pubblicati prima del 224, anno in cui fu eretto il monumento.
Molto numerose sono le opere attribuite alla mano di Ippolito, sull’autenticità delle quali però non sempre concorde risulta il parere degli studiosi. Mi limiterò pertanto a richiamare le più importanti:
• Il Syntagma, o Riassunto contro trentadue eresie. Questo breve trattato appartiene al primo periodo dell’attività di Ippolito, durante il pontificato di Zefirino (199-217).
• I Philosophumena. È la più importante delle opere di Ippolito. Composta dopo il 222, è conosciuta e citata con diversi titoli, a cominciare da quello con cui la designò l’autore: Elenchos, o Confutazione di tutte le eresie. L’opera comprende complessivamente dieci libri. Il titolo Philosophumena significa Esposizione delle dottrine filosofiche; come tale, si riferisce ai soli primi quattro libri, che trattano della filosofia dei greci. I libri restanti (V-IX) tendono a dimostrare che tutte le eresie non fanno che attingere alle dottrine dei filosofi pagani, ai misteri e all’astrologia, e non alla Scrittura e alla Tradizione della chiesa. Il decimo libro, incompiuto, riassume teorie filosofiche ed eretiche già in precedenza trattate.
• L’Anticristo è la sola opera di Ippolito che ci sia pervenuta completa: fu scritta verso il 200. L’autore dichiara che I ‘apparizione dell’Anticristo non può ritenersi imminente.
• Della tradizione apostolica. L’opera risulta anzitutto un testo di liturgia pressoché codificato, e si riferisce alla consacrazione del vescovo, seguita dalla celebrazione della messa pontificale: una liturgia eucaristica destinata ad avere grande influsso sulla tradizione liturgica posteriore, soprattutto in Occidente. Quindi ha luogo l’amministrazione del battesimo, con tutti i particolari del rito battesimale.
• Non mancano altre opere più brevi, di carattere esegetico, come il Commento a Daniele e parecchie Omelie.
Nella Tradizione apostolica si trova la Preghiera eucaristica che rappresenta il canone più antico che si conosca. Ad esso si ispira direttamente, come risulta dalla prossima lettura, la seconda preghiera eucaristica della liturgia oggi introdotta.
Lettura
Preghiera eucaristica
«Per compiere la tua volontà e per conquistarti un popolo santo, Gesù Cristo ha teso le mani nella passione per liberare dalla sofferenza coloro che hanno fiducia in Te. E, accettando volontariamente la sofferenza per distruggere la morte [...] e manifestare la risurrezione, prendendo il pane, ti rese grazie e disse: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo, che sarà spezzato per voi”. Lo stesso fece con il calice, dicendo: “Questo è il mio sangue, che verrà sparso per voi. Quando fate questo, fatelo in memoria di me”».
(La Tradizione apostolica, 4. Tr. di R. Tateo, Ippolito di Roma: La Tradizione apostolica, Alba 1972, pp. 84ss)
Nello studio della personalità di Ippolito, appare anzitutto il rappresentante del vecchio presbiterato romano, di cui ci tramanda la tradizione catechetica e le usanze liturgiche. Non manca però un altro aspetto del suo temperamento, vale a dire un certo qual spirito reazionario. Egli non si rese conto che lo sviluppo del popolo di Dio porta con sé situazioni nuove e che il cristianesimo non è una setta di puri, ma la città di tutti gli uomini. A parte questo, non c’è nessun motivo di farne uno scismatico. I suoi scritti respirano la più pura Tradizione. La sua violenza dipende in buona parte da un genere letterario. E’ stato il rappresentante di un «integrismo» che la gerarchia ha avuto ragione di non accettare. Ma è stato ugualmente un grande dottore della chiesa. (1)
Per l’approfondimento
Edizioni
PG 10,16,3; GCS 1,1 (1891) 1-340; 1,2 (1897) 1-47; 26(1916)1- 293; B. Botte, Hyppolite de Rame: la Tradition Apostolique (SCh 11), Paris 1946; P. Nautin, Hippolyte: Contre les hérésies, Paris 1949, pp. 19-37; IDEM, Homélies pascales (SChI 27), Paris 1950; IDEM, Hyppolite et Josipe, Paris 1947.
Traduzioni
E. Norelli, L’Anticristo, Firenze 1987; R. Tateo, La Tradizione apostolica, Roma 1979.
Studi
L’accesso più comodo alla bibliografia generale ippolitea è costituito dai due voll.: Ricerche su Ippolito (Sea 13), Roma 1977, e Nuove Ricerche su Ippolito (Sea 30), Roma 1989, che forniscono anche le più aggiornate prospettive di ricerca. In quest’ultimo volume è contenuto lo studio di M. Guarducci sulla statua della Biblioteca Vaticana (pp. 61ss).
1) Cf. J. Daniélou, Nuova storia della chiesa, Torino 1970, p. 145.Minucio Felice (Lorenzo Dattrino)
MINUCIO FELICE
di Lorenzo Dattrino
Della sua vita abbiamo alcune notizie da Girolamo: «Minucio Felice, distinto avvocato in Roma, scrisse un dialogo, in cui riporta una discussione tra un cristiano e un pagano, intitolato Octavius (Ottavio). Sotto il suo nome circola pur un altro libro Sul destino o contro i matematici; ma per quanto sia opera d’uomo di talento, non mi sembra concordi nello stile con l’opera già menzionata. Minucio è altresì ricordato da Lattanzio nelle sue opere». (1)
Indubbiamente il nostro uomo appartenne a un’età compresa fra gli ultimi decenni del Il secolo e gli inizi del III. Sembra ormai accertato che la sua patria fu l’Africa, (probabilmente Cirta, oggi Costantina, Algeria). Presto egli si portò a Roma, dove esercitò l’avvocatura. Era dapprima pagano: si ignora se la sua conversione avvenisse prima del suo arrivo nella capitale dell’impero, oppure dopo.
L’opera, intitolata Ottavio, si presenta in forma di dialogo, svolto da parte di tre intimi amici: Cecilio Natale, pagano; lanuario Ottavio, cristiano e Minucio Felice, arbitro tra i due interlocutori. L’occasione che diede motivo alla discussione fu un bacio che Cecilio, il pagano, aveva indirizzato, come espressione di religioso ossequio, alla statua di Serapide, davanti alla quale erano venuti a trovarsi i tre amici, mentre compivano una loro serena passeggiata lungo la strada che da Ostia portava a Roma.
L’opera si articola nelle seguenti parti: dopo una breve introduzione (cc. 1-4), ecco un’esposizione del paganesimo, dichiarata con piena convinzione da parte di Cecilio (cc. 5-13). Interviene allora Ottavio con una risposta di ben maggiore convinzione in difesa del cristianesimo (cc. 14-38)
Il carattere di quest’opera è strettamente apologetico. Specialmente in passato essa è stata oggetto di indiscussa ammirazione. Rimangono tuttavia alcuni problemi ancora insoluti. Resta dubbia innanzitutto una prima questione: il dialogo è realmente avvenuto, oppure è opera d’una mera finzione letteraria? I critici rilevano, nella struttura dell’opera, la presenza di due orazioni abilmente introdotte dall’autore stesso e poi collegate fra loro, così da risultarne un dialogo.
Dopo tutto, lo scrittore si sofferma poco sulla trattazione dei dogmi e sui principi essenziali della fede cristiana, come tale. Egli sa che di fronte al suo obiettore deve difendere il cristianesimo più nella sua parte esteriore che non per la profondità dei suoi dogmi. Pertanto «le ragioni delle caratteristiche dell’opera di Minucio vanno ricercate nell’epoca in cui l’autore visse, come pure nell’educazione e nel carattere della sua mentalità, ben diversa dal carattere e dalla mentalità di un Tertulliano». (2) Quella che egli intende difendere e valutare è la vita dei cristiani, ben più che il complesso dottrinale della loro fede.1) Girolamo, De viris illustribus, Torino 1971 (trad. di E. Camisani), p. 166
2) U. Moricca, Letteratura latina, I, pp. 84-85.
Per l’approfondimento
Edizioni
L 3,231-360; CSEL 2.1-71
Traduzioni
E. Paratore, Minucio Felice: Ottavio, Bari 1971; L. Rusca, Minucio Felice: Ottavio. Contraddittorio tra un pagano e un cristiano, Milano 1957
Studi
E. Paratore, La questione Tertulliano-Minucio, ha «Ricerche Religiose» 18 (1947), 132-159; I. Vecchiotti, La filosofia politica di Minucio Felice, Urbino 1974 Girolamo, De viris illustribus, Torino 1971 (trad. di E. Camisani), p. 166 U. Moricca, Letteratura latina, I, pp. 84-85.Nicola Cabasilas, il laico che fu maestro di spiritualità (Marco Ronconi)
Nicola Cabasilas,
il laico che fu maestro di spiritualità
di Marco Ronconi

Nicola Cabasilas (1322-1391/97), santo della Chiesa bizantina, ha goduto nella cristianità latina una notevole e per certi versi curiosa autorevolezza, che non sembra fortunatamente declinare. I suoi testi - di un autore non cattolico - sono stati utilizzati sia al Concilio di Trento, sia al Vaticano Il. Senza volontà di precisione, si trovano sue citazioni in Jacques-Bénigne Bossuet, Giuseppe Dossetti, Joseph Ratzinger, Paolo VI e Giovanni Paolo Il. A un suo passo si è rifatto il Predicatore della Casa Pontificia lo scorso venerdì santo, mentre il suo nome è presente in Orientale Lumen e nella più recente enciclica Ecclesia de Eucharestia. Anche l’ultimo convegno ecumenico tenutosi al monastero di Bose lo scorso settembre, ha analizzato la figura di questo laico cristiano, che vale forse la pena conoscere più a fondo.
La lite tra Girolamo e Rufino, due umani padri della Chiesa (Marco Ronconi)
La lite tra Girolamo e Rufino,
due umani padri della Chiesa
di Marco Ronconi *

Se perfino tra Girolamo e Rufino è scoppiata la « discordia che ora ci fa piangere, quale amico non si potrà d’ora in poi temere come un possibile futuro nemico?». Sant’Agostino cercava così, nel 404, di appianare un dissidio che fece epoca e che, a raccontarlo, sembra un romanzo. Girolamo dì Stridone è lo stesso san Girolamo cui si attribuisce l’inizio della traduzione latina della Bibbia, la cosiddetta Vulgata. Le sue opere sono capisaldi dell’arte poetica cristiana, dell’esegesi e della letteratura ascetica. Già prima di divenire segretario di papa Damaso, la padronanza della retorica latina e greca, oltre che la discreta conoscenza dell’ebraico, ne facevano un intellettuale ricercato da molti, famoso per la rara competenza cosmopolita, ma anche per il carattere passionale e poco incline alla diplomazia. Rufino di Concordia non fu mai elevato agli altari, ma a lui si rifecero, tra gli altri, Agostino, Giovanni Cassiano, Cassiodoro, Benedetto da Norcia e Isidoro di Siviglia. Secondo j. Gribomont e buona parte della critica contemporanea, le traduzioni che elaborò dal greco al latino di opere capitali per la cristianità hanno «recato un contributo decisivo alla cultura, biblica e non, del Medioevo latino». E grazie a lui, ad esempio, se ancora oggi conosciamo alcuni testi di Origene, andati perduti nell’originale.
Entrambi cresciuti vicino ad Aquileia alla scuola del vescovo Cromazio, entrambi traduttori ed esegeti, entrambi monaci e legati a nobildonne romane (Melania per Rufino e Paola per Girolamo), con cui fondarono monasteri in due diversi punti di Gerusalemme, avevano chiaramente idee diverse sui metodi di traduzione della Bibbia e sull’interpretazione della vita ascetica, ma nessuno immaginava quanto sarebbe accaduto nella controversia su Origene, il primo intellettuale cristiano di livello enciclopedico, vissuto ad Alessandria nel III secolo. La controversia nacque dal fatto che i testi di Origene, scritti evidentemente prima delle elaborazioni dottrinali dei grandi concili, si prestavano a interpretazioni difficili. All’epoca di Girolamo e Rufino, erano guardate con sospetto alcune sue spiegazioni sulla resurrezione della carne, sulla salvezza del diavolo, sull’esegesi allegorica e sulla preesistenza delle anime.
Nel 398, in particolare, inizia una “raccolta di firme” per mettere all’indice l’alessandrino. Girolamo, che pure ha mostrato fino a quel punto incomparabile stima per colui che ha elogiato come grandissimo maestro aderisce al movimento antiorigenista, suscitando le critiche di molti, tra cui Rufino, che lo bollano in modo sottile ma inequivocabile come un traditore. Per lettera, volano parole grosse - soprattutto da parte di Girolamo - ma i due, complici anche amici comuni, riescono a riconciliarsi quasi subito, al punto che Rufino, presentando la traduzione di una delle opere più notevoli di Origene, cita Girolamo come modello del particolare metodo adottato. Il cardinale della Repubblica ceca Tomàš Špidllìk lo spiega così: «Non tutti coloro che traducono letteralmente i termini rendono bene anche il pensiero dell’autore. Per comprendere bene un testo bisogna amarlo. Ed è ciò che fa Rufino. Egli ammira il pensiero di Origene e perciò, nonostante la sua libertà nei termini, rende spesso meglio le idee principali del grande maestro alessandrino». Per preservare il buono della dottrina di Origene, quindi, non esita a smussare, togliere e ricomporre i testi, come del resto era costume tipico dell’epoca.
Il problema è che quando Girolamo legge la dedica, va su tutte le furie. Non vuole in nessun modo il suo nome legato all’alessandrino e, tra gli epiteti più lievi con cui parla di Rufino, risuonano «scorpione», «asino», «canaglia». Traduce poi la stessa opera senza nessuno degli accomodamenti di Rufino, per mostrare non solo quanto sia pericolosa, ma anche quanto poco credibile sia il lavoro dell’ex amico. Questi dà allora alle stampe un’Apologia, in cui ribatte chiedendo a Girolamo: «Che cosa è più audace e temerario: tradurre questi libri di Origene, dei quali quasi tutta la materia avevi già esposto in altre opere e tutte le dottrine che ora condanni avevi già pubblicate in opere tue: oppure alterare i libri della Sacra Scrittura [...] basandoti su una traduzione nuova del testo ebraico? Quale di queste due azioni ti sembra più illecita?». La tenzone crescerà ancora, fino a livelli d’acrimonia e di colore stupefacenti, su cui non ci addentriamo oltre. A un certo punto Rufino smise di replicare, mentre «finalmente è stata schiacciata la testa dell’idra», è la non criptica frase con cui Girolamo commentò la morte dell’altro.
Personalmente, pur comprendendo lo scoramento di Agostino, quando mi capita oggi di considerare l’importanza che hanno avuto le opere di questi uomini nella tradizione cristiana, avverto un qualche retrogusto di consolazione: amo infatti immaginare Girolamo e Rufino da qualche parte, sotto lo sguardo paziente e vigilante di un angelo, continuare ancora a discutere animatamente, l’uno un po’ più burbero e focoso, l’altro più sospirante e silenzioso, e capisco sempre più come il termine “Padri della Chiesa” sia sapientemente ricco di umanità e soprattutto plurale.
* teologo e insegnante di religione
(da Jesus, dicembre 2006)
Il III secolo (Lorenzo Dattrino)
Il III secolodi Lorenzo Dattrino
Mentre in Oriente fiorivano Clemente e Origene, ormai aperti agli influssi dell’ellenismo, in Occidente gli uomini di chiesa, fatte poche eccezioni, sembravano estranei a ogni impegno inteso a conciliare fede cristiana e dottrina greca. Ma c’era di più. Anziché spingersi nei campi rischiosi delle ricerche dottrinalmente ardite per tentare di spiegare i misteri divini, gli occidentali preferivano rimanere docilmente sicuri nell’accettazione delle norme tradizionali dell loro fede. Se poi si vuole penetrare maggiormente in questa divisione, tendente a sottolineare la diversa mentalità tradizionale e dottrinale dell’Oriente e dell’Occidente, emergerà chiaramente l’impossibilità, per gli occidentali, di distinguere, tra i fedeli, le due categorie dei semplici credenti e dei «perfetti»: i primi considerati e, per così dire, catalogati in un grado inferiore, perché cresciuti nella pura accettazione delle verità rivelate, i secondi invece ritenuti ormai elevati in un grado superiore per aver raggiunto la vera «gnosi», il privilegio di una scienza ben più profonda dei misteri divini.
Uno dei fattori più decisivi, atti a spiegare il ritardo di una letteratura tutta propria dell’Occidente, va cercato nel dominio incontrastato esercitato dalla persistenza, anche in Occidente, della lingua greca, particolarmente come lingua di cultura. E questo avvenne certo in campo profano; si pensi che lo stesso Marco Aurelio scrisse in greco i suoi Ricordi, e siamo già negli anni tra i 161 e il 180, ma avvenne anche in campo cristiano. Le opere letterarie scritte in Roma e nell’Occidente fino alla fine del Il secolo furono scritte in lingua greca: così la Lettera di Clemente ai Corinti, il Pastore d’Erma, gli scritti di Giustino e di Ireneo. Il bisogno d’una letteratura in lingua latina cominciò a farsi sentire quando, nell’accresciuto numero dei credenti in Cristo, reclutati anche fuori dell’ambiente giudaico da tutti i ceti sociali, erano ormai troppo numerosi coloro per i quali non era familiare la lingua greca. (1)
Nota
Il commento di Girolamo al profeta Isaia (Iginio Passerini)
Il commento di Girolamo
al profeta Isaia
di Iginio Passerini

Era nato a Stridone in Dalmazia verso il 347. Compiuti gli studi letterari a Roma, dove era stato battezzato, aveva raggiunto Treviri, sede imperiale, dove aveva maturato la decisione di dedicarsi all'ideale ascetico. Si era congiunto per questo, verso il370 ad Aquileia, con un gruppo che aveva le medesime intenzioni (Rufino, Bonoso, Cromazio, Eliodoro). Ma nel 373 ilgruppo si era sciolto e Girolamo partiva per Antiochia di Siria, per sperimentare la vita monastica in forma eremitica nel deserto di Calcide, tutto dedito allo studio linguistico ed esegetico della Scrittura, alle opere patristiche e alla trascrizione di codici. L'esperienza sostenuta in forme assai dure lo maturerà come guida e maestro di ascesi per gli anni successivi.
Nel 382 si trasferì a Roma, dove papa Damaso lo fece suo segretario. Qui attese alla versione latina di quasi tutta la Bibbia, mentre si interessava degli ideali ascetici che circolavano in alcuni ambienti aristocratici femminili della città.
Alla morte di papa Damaso, avvenuta nel dicembre 384, Girolamo riprese la via dell'Oriente. Con il fratello Paoliniano e con alcuni monaci nell'estate del 385 si imbarcò per Antiochia, accompagnato da Paola ed Eustochio, ormai votate all'ideale ascetico.
Nella primavera/estate del 386 ilgruppo si stabilì a Betlemme, e presso la Basilica della Natività, grazie ai finanziamenti della facoltosa Paola, vennero fondati due monasteri, uno per i monaci e uno per le vergini, con una foresteria per i pellegrini. Qui Girolamo si dedicò interamente all'attività letteraria: traduzioni bibliche, adattamenti di commentari, qualche romanzo agiografico, raccolta di dati storici. Ai monaci spiegò la Scrittura e offrì istruzioni ascetiche; ai giovani, nella scuola annessa al monastero, insegnò grammatica latina e letteratura classica; mantenne i contatti con amici di Roma; partecipò alle vicende della Chiesa.
400 ilcommento ai profeti maggiori, dove ildebito verso Origene, purificato dalle posizioni controverse, è decisamente abbondante, nel caso in cui Girolamo disponga della fonte.Nel frattempo la vita di Girolamo aveva ricevuto diversi colpi: era morta Paola nel 404; Roma fu distrutta dai Goti nel 410; nel 418/419 morì anche Eustochio. E a pochi mesi di distanza da questo lutto, anche Girolamo si spense a Betlemme il30 settembre 419, mentre stava commentando Geremia, l'ultimo del ciclo dei profeti.
* * *
Il Commento a Isaia (1) appartiene agli anni 408-409: siamo ormai nell'ultima fase dell'attività esegetica, quando il criterio ermeneutico di Girolamo ha raggiunto la sua più matura formulazione e applicazione. Scrive nel Prologo: commento a Daniele, mi costringi, vergine di Cristo Eustochio, a passare al commento di Isaia (…). Rendo a te ciò che devo, obbedendo ai comandi di Cristo, che dice: Scrutate le Scritture (Mt 7,7); e: Cercate e troverete (Mt 22,29). Per non sentirmi dire, insieme ai Giudei: Vagate, ignorando le Scritture e la potenza di Dio (Mt 22,29). Se infatti, secondo l'apostolo Paolo Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio e colui che non conosce le Scritture non conosce la potenza di Dio e la sua sapienza, allora ignorare le Scritture è ignorare Cristo. Quindi sostenuto dall'aiuto delle tue preghiere, dato che giorno e notte tu mediti la legge di Dio e sei tempio dello Spirito Santo, imiterò il padrone di casa, che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e antiche; imiterò la sposa che dice nel Cantico dei cantici: Cose nuove e antiche fratello mio ho conservato per te (Ct 7,13); e così esporrò Isaia, in modo da presentarlo non solo come profeta, ma anche come evangelista ed apostolo. Egli stesso di sé e degli altri evangelisti dice: Quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano il bene, che annunciano la pace (Is 52,7). E a lui come ad un apostolo Dio si rivolge in questi termini: Chi manderò e chi andrà da questo popolo? Ed egli risponde Eccomi, manda me (Is 6,8)».Il commentario è molto esteso (18 libri) ed applica sistematicamente i criteri che si sono progressivamente delineati nel corso della sua multiforme attività esegetica:
Nella lettera 120,12 riprendendo Origene, aveva riconosciuto tre livelli di esegesi: quello letterale, quello morale, quello spirituale. Generalmente però non si riconosce in questo schema ternario, ma preferisce quello binario, attento alla lettera del testo accompagnata da un'interpretazione di carattere allegoric.o (2) Così Girolamo fa sistematicamente nel commento ad Isaia: premessa l'attenzione al livello letterale, ancora più costantemente che in altri commenti, sviluppa discretamente l'interpretazione allegorica. Lo dimostra anche il fatto che, mentre in un saggio esegetico del 397 sui capitoli 13-23 di Isaia, gli oracoli contro le nazioni erano stati esaminati solo in chiave letterale, allo stesso commento riproposto tale e quale in quest'opera nel libro 5°, fa seguito l'interpretazione allegorica degli stessi capitoli nei libri 6° e 7°. (3)a) anzitutto un'aderenza critica al testo, spesso con duplice riferimento, per la scelta della lezione, all'originale ebraico e al testo greco dei LXX;
b) in secondo luogo egli è attento sistematicamente a due livelli di interpretazione: il primo è quello letterale (littera o historia); l'altro è quello spirituale (allegoria, anagogè, tropologia, spiritus).
Così si esprime Girolamo nel Prologo del suo commentario:
«All'interpretazione letterale (historiae veritatem) deve seguire quella spirituale (spiritaliter accipienda sunt omnia); così Giudea e Gerusalemme, Babilonia e Filistea, Moab e Damasco, Egitto e deserto, Idumea e Arabia, la valle della Visione fino all' estremità di Tiro, la visione dei quadrupedi sono tutte realtà da interpretare, per coglierne il significato e riconoscere che in esse l'apostolo Paolo come sapiente architetto ha posto il fondamento, che non è altro che Cristo Gesù».
E sulla necessità di accedere al livello profondo dell' interpretazione, là dove non arrivano coloro che non hanno la fede in Cristo e la sua luce, siano essi pagani o giudei, aveva appena detto, sempre nel Prologo:
«Nessuno pensi che voglia contenere l'argomento di questo testo in una breve trattazione, perché questo libro contiene tutti i misteri (sacramenta) del Signore e vi si predica sia l'Emmanuele nato dalla vergine, sia colui che ha compiuto opere mirabili e gesti significativi, morto sepolto e risorto dagli inferi è il Salvatore di tutte le genti. Che dirò dei contenuti di fisica, etica e logica? Tutto ciò che è proprio delle sante Scritture, tutto ciò che può proferire lingua umana, ciò che i sensi dei mortali possono ricevere, tutto quanto è contenuto in questo libro. Dei suoi misteri rende testimonianza colui che scrisse: E sarà per voi la visione di tutto come le parole di un libro sigillato, che viene consegnato a uno che sa leggere, dicendogli: Leggilo. E quello risponde: Non posso, perché è sigillato. E verrà consegnato il libro a chi non sa leggere, dicendogli: Leggi. E risponderà: Non so leggere (Is 29,11.12). Sia dunque che tu consegni questo libro al popolo dei pagani che non sa leggere, ti risponderà: Non posso leggere, perché non ho imparato a leggere le Scritture. Sia che lo consegni agli scribi e ai farisei, che si vantano di conoscere le lettere della Legge, risponderanno: Non possiamo leggere, perché il libro è sigillato. Come mai è sigillato proprio per essi? Perché non hanno accolto colui sul quale il Padre ha posto il sigillo, colui che tiene la chiave di Davide: Colui che apre e nessuno può chiudere; che chiude e nessuno può aprire (Ap 3,7)».
Le fonti del commento di Girolamo sono esplicitamente ammesse nel Prologo della sua opera, dove dichiara di aver attinto le spiegazioni allegoriche al commento di alcuni ecclesiastici viri. Si tratta del commento di Eusebio di Cesarea prevalentemente di carattere letterale; inoltre per gli sviluppi allegorici Girolamo si è rifatto sia al commentario di Origene in 30 libri (Girolamo dichiara di non disporre del libro 26), che si fermava al passo di Is 30,5; sia al commentario di Didimo di Alessandria per Is 40-66.Tra le fonti latine ricorda solo Vittorino di Petovio, in un suo commento perduto a Isaia. Nel commento di Girolamo il registro dell' interpretazione letterale riprende da Eusebio il motivo del trasferimento dei riferimenti profetici dal tempo delle invasioni assira e babilonese al tempo delle guerre con i romani, con spazi anche per una lettura cristologica. L'interpretazione allegorica attinge ai temi più cari ad Eusebio, come la vittoria della Chiesa sull'idolatria pagana e la sostituzione della Chiesa ad Israele, ma anche a temi tipici di Origene e di Didimo, quali il confronto con l'eresia e il rapporto individuale di Cristo con l'anima del cristiano. Dichiara Girolamo, sempre nel Prologo:
«Voler commentare tutto il libro di Isaia è un impegno di grande portata, con cui si è misurato l'ingegno dei nostri padri, dico dei Greci. Per il resto tra i latini c'è grande silenzio, fatta eccezione per il martire di santa memoria Vittorino, che poteva dire con l'apostolo: Anche se inesperto nel linguaggio, non però nella scienza. Origene ha scritto su questo profeta, fino alla visione dei quadrupedi nel deserto, trenta volumi, di cui non si trova il 26°. Sono a lui attribuiti altri due libri sulla visione dei quadrupedi, che sono ritenuti non autentici; cosippure venticinque omelie e Semeiòseis, che noi possiamo chiamare Excerpta. Anche Eusebio Panfilo ha pubblicato quindici libri secondo la spiegazione storica (= interpretazione letterale); e Didimo, della cui amicizia ci siamo avvalsi, dal passo dove sta scritto: "Consolate, consolate il mio popolo, sacerdoti; parlate al cuore di Gerusalemme", fino alla fine del libro, ha pubblicato diciotto volumi. Apollinare poi, secondo il suo stile tocca tutti i passaggi ( ... ) ma in modo che ci sembra di leggere non tanto dei commenti, quanto piuttosto un indice per sommi capi».
Il riferimento a queste fonti non toglie nulla all'originalità della sua esegesi, espressa in una forma letteraria degna di un grande scrittore della tarda antichità.
Note
1) Il commento di Girolamo ad Isaia è apparso in edizione critica nel «Corpus Christianorum» nel 1963 ad opera di M. Adriaen: S. HIERONYMI PRESBYTERI, Commentariorum in Esaiam libri, curo M. ADRIAEN, Turnholti 1963, CCSL 73-73A.2) Vedi P. JAY, Saint Jérome et le triple sens de l'Ecriture, in «Revue des Etudes Augustiniennes» 26 (1980),214-227.
3) Vedi M. SIMONETTI, Sulle fonti del «Commento a Isaia» di Girolamo, in «Augustinianum» 24 (1984), 451-469; ID., Lettera e/o allegoria, Studia Epherneridis «Augustinianum» 23, Roma 1985,334-336.
(da Parole di Vita, 1, 1999)
Elementi di attualità della riflessione patristica sulla gnosi (Lorenzo Dattrino)
Elementi di attualità
della riflessione patristica sulla gnosi
Lorenzo Dattrino

Il complesso mondo dei nuovi movimenti religiosi (es. la New Age, Scientologia , ecc.) ripresenta oggi elementi che hanno non poche analogie con un fenomeno culturale apparso nei primi secoli dell’era cristiana. Detto fenomeno viene conosciuto con il termine gnosticismo. È necessaria una premessa terminologica.
Il termine gnosticismoè di origine moderna, e viene generalmente inteso in senso tecnico, ad indicare, cioè quel particolare fenomeno religioso che si è sviluppato nell’area mediterranea nei primi tre secoli della nostra era, dando origine a diversi sistemi e scuole che, sulla base delle testimonianze contemporanee, sono comunemente denominati gnostici. Il termine gnosi (dal greco gnồsis= conoscenza), invece, presenta una certa ambiguità. Alcuni attribuiscono anche a questo termine un significato tecnico ( più generico, però, di gnosticismo ) e lo riferiscono a quel particolare tipo di conoscenza religiosa (di Dio e dei suoi misteri; della vera natura dell’uomo e del mondo ecc.), riservata ad una élite , che da sola opera la salvezza e la liberazione di chi la possiede; in questo senso, non ogni conoscenza religiosa è propriamente una . Per estensione il termine può indicare inoltre anche i movimenti religiosi che tale dottrina della conoscenza hanno espresso. Gnosi, però, può essere utilizzato anche come semplice traduzione del termine greco dal quale deriva, vale a dire nel senso di “ conoscenza “ (di chi o di che cosa, dovrà essere specificato a seconda dei contesti). Si tratterà comunque sempre di un particolare tipo di conoscenza legato all’ambito religioso, che si distingue, p.es., dalla conoscenza di tipo scientifico, espressa in greco dal termine epistème.
La gnosi non è all’origine una nozione estranea né al giudaismo né al cristianesimo. Essa diventa un tema scottante per il cristianesimo soprattutto durante i secoli II e III d. C., che videro svilupparsi, da un lato, vari movimenti gnostici (di origine cristiana e non) che, nell’ottica dei Padri della Chiesa, furono assimilati all’eresia; e dall’altro, nuove scuole filosofiche ( soprattutto il platonismo medio nel sec. II e il neoplatonismo nel sec. III ) che dimostrarono un rinnovato interesse per il tema della conoscenza soprattutto in riferimento al problema della conoscenza di Dio.
Il contesto socio-culturale
Vediamo qual è lo sfondo culturale in cui sorge lo gnosticismo antico.
Il "crollo della polis“, che aveva caratterizzato l’esordio dell’età ellenistica, aveva portato in ambito filosofico e culturale ad una serie di mutamenti di ampia portata ; gli uomini (bruscamente strappati da quel “piccolo cosmo a misura d’uomo“ che erano – per i cittadini liberi – le poleis) abbandonarono le speculazioni di tipo metafisico per rifugiarsi in sistemi moralistici dallo scarso spessore teoretico, ma dalle formidabili valenze etico-pratiche.
Tale “ripiegamento involutivo“ seguiva una delle più profonde stagioni speculative della filosofia greca, quella caratterizzata dalle figure di Platone e di Aristotele, i cui insegnamenti furono dimenticati o apertamente osteggiati.
Il cammino della riscoperta di quella dimensione soprasensibile individuata da Platone con la sua “ seconda navigazione “ e poi dimenticata dai moralisti scettici o dogmatici della prima stagione dell’età ellenistica sarà lungo e difficile, non privo di esitazioni e travisamenti. I grandi sistemi filosofici di età ellenistica (Stoicismo, Epicureismo e Scetticismo) rispondevano al bisogno di certe etiche immediate, proprio degli uomini del loro tempo, ma lo facevano al prezzo di pressochè totale oblio dei frutti della “ seconda navigazione “ platonica: il cosmo viene ridotto alla sua sola dimensione fisica e la filosofia si riduce ad un sistema, costituito di tre parti o “ branche “, ben determinate (logica, fisica ed etica).
Col tempo entra in crisi il fisicismo dogmatico di tali filosofie ed emerge l’istanza di riscoprire una dimensione soprasensibile della realtà, andandola a cercare nel cuore del pensiero di quell’autore che l’aveva posta al centro della sua speculazione: Platone, che in quest’epoca viene sovente associato a Pitagora. Il cosiddetto “medioplatonismo” e il “neopitagorismo“ sono movimenti di pensiero che si collocano in tale solco.
Il problema etico resta preminente anche nell’orizzonte speculativo dei medioplatonici, però il motto fondamentale non è più quello delle filosofie ellenistiche (“segui la natura“), ma diventa, significativamente : “assimilati a Dio“.
E' evidente che questo clima caratteristico dei sec. II-III ha esercitato un influsso sul cristianesimo e che i padri della chiesa, nello sviluppo delle loro riflessioni sul tema della gnosi, si sono dovuti confrontare con esso.
L’atteggiamento dei cristiani colti
Le dottrine filosofiche che più influirono sul pensiero cristiano dei primi secoli sono lo stoicismo e il platonismo. Fra i cristiani, l’accettazione della filosofia greca non fu subito cosa ovvia. Contrasti ed opposizioni si manifestarono molto presto e tra gli stessi apologisti del sec. II, i primi autori cristiani che abbiano cercato di gettare un ponte tra il cristianesimo e la filosofia greca, non mancarono atteggiamenti di ripulsa. I più noti oppositori furono Taziano (per il cristianesimo di lingua greca) e Tertulliano (per quello di lingua latina). Secondo questi autori, il cristianesimo è del tutto estraneo alla filosofia greca; quest’ultima non contiene altro che deformazioni della verità ed è inoltre, con le dottrine delle sue diverse scuole, all’origine di tutte le eresie.
Tuttavia, la necessità di rispondere alle accuse che muovevano al cristianesimo i pagani delle classi colte e di diffondere anche tra queste classi la nuova fede fu un importante argomento a favore della diffusione della filosofia greca fra i cristiani. Lo stoicismo influì soprattutto sulle dottrine etiche, il platonismo sulla riflessione teorica dei primi pensatori cristiani. In particolare, la filosofia platonica, così come era stata riformulata dai pensatori del platonismo medio, arricchita anche da influssi neopitagorici, gravitava sempre di più verso la conoscenza del divino, fino a culminare in quella disciplina che dai filosofi aristotelici ha preso il nome di teologia e il cui fine ultimo è la homoiộsis theộ,il farsi simili a Dio. Proprio per queste sue caratteristiche, la filosofia platonica si presentava come uno strumento particolarmente adatto a tradurre il messaggio cristiano in un linguaggio comprensibile all’uomo di cultura greca, e in quanto tale fu utilizzato dai primi grandi pensatori cristiani, da Giustino a Clemente e ad Origene.
Ma l’interesse del nascente pensiero cristiano nei confronti del platonismo, la disponibilità ad utilizzare temi di origine platonica nella riflessione sui dati della fede cristiana non devono far pensare che la distanza fra le due dottrine fosse minima. Come tra gli apologisti non mancarono oppositori nei confronti della cultura greca, così già nel sec. II si alzarono tra i filosofi medioplatonici alcune voci polemiche contro il cristianesimo : verso il 180 d.c. Celso scrive contro i cristiani quel Discorso verace, volto a dimostrare l’assoluta inconciliabilità tra filosofia greca e cristianesimo, che Origene confuterà circa 70 anni più tardi, conservandocene larghi estratti, nella sua opera Contro Celso. A lui farà eco il medico Galeno, riprendendo sostanzialmente gli stessi argomenti di Celso, che sono quelli tipici del medioplatonismo, di una filosofia, cioè, orientata sì in senso teologico, ma in nessun modo disposta ad abbandonare la ragione per aderire ad una fede.
Il filosofo Giustino è il primo esempio tipico di questo genere di avventura intellettuale e religiosa.
La sua nascita si colloca a Flavia Neapolis, l’antica Sichem, verso l’inizio del secondo secolo. Ci ha narrato lui stesso il suo itinerario in Dialogo con Trifone. Dopo aver interpellato tutte le filosofie, solo dalla platonica ha un aiuto, ma sono la lettura della Bibbia e la preghiera che conducono Giustino alla fede cristiana. Quando vi ha pienamente aderito, lungi dall’abbandonare la sua esistenza filosofica, egli considera che ha trovato, come gli aveva detto il vegliardo, la vera filosofia. Indossando sempre il pallio egli si fisserà, sotto Antonino Pio, a Roma e vi aprirà una scuola filosofica in cui il cristianesimo è proposto come la vera filosofia. Taziano, l’altro grande apologista siriano, diventerà suo discepolo. Ma con esiti opposti!
L’accoglienza fatta al pensiero greco riguardo al Logos grava con un certo peso sul lessico e sul pensiero di Giustino. La stessa cosa è vera per gli altri apologisti, e le conseguenze si faranno sentire fino a due secoli più tardi durante la crisi ariana.
Fonti per la conoscenza del fenomeno gnostico
Vediamo di far tesoro delle fontes in nostro possesso per conoscere meglio il fenomeno culturale dello gnosticismo. Esso ci è noto attraverso due tipi di fonti: le testimonianze patristiche (fonti indirette) e gli scritti di autori gnostici (fonti dirette). I padri della chiesa consideravano lo gnosticismo come un’eresia sorta in seno al cristianesimo e che ne minacciava l’integrità. Si sono quindi adoperati in ogni modo per confutarlo. Le informazioni più importanti ci vengono dagli eresiologi (Ireneo di Lione; Ippolito di Roma ; Tertulliano ; Epifanio di Salamina), quei padri della chiesa, cioè, che avevano fatto della lotta contro le eresie l’impegno principale della loro attività di scrittori. Fino ad alcune decine di anni or sono, le testimonianze patristiche costituivano la fonte di informazione principale, se non esclusiva, sullo gnosticismo.
Oggi, in seguito alla scoperta, avvenuta nel 1946 nei pressi della cittadina di Nag Hammadi, in alto Egitto, di una biblioteca gnostica, composta di 13 codici papiracei abbastanza ben conservati, che contengono una cinquantina di opere di autori gnostici, siamo potuti venire a contatto con scritti di prima mano, che documentano in modo diretto (non solo attraverso la prospettiva dei suoi avversari) il fenomeno gnostico. Questi scritti rappresentano la traduzione in copto, databile alla metà circa del sec. IV, di opere originariamente scritte in greco e che possono risalire fino al sec. I d.C. Tra i testi di Nag Hammadi, alcuni presentano caratteri pienamente cristiani, mentre altri, pur essendo gnostici, non rivelano alcun punto di contatto con il cristianesimo. Lo gnosticismo si presenta come un movimento religioso estremamente complesso e variegato, a carattere sincretistico (in cui si compongono , cioè, elementi di origine diversa). Le testimonianze letterarie del sec. II documentano in effetti una varietà di comportamenti e di dottrine che vanno, per quanto riguarda l’etica, dall’ascetismo più rigido ad atteggiamenti antinomisti e a pratiche libertine; per quanto riguarda la prassi liturgica, dai rituali misterici a pratiche giudaiche e cristiane; per quanto riguarda la teologia, dalla riflessione filosofica più sottile e rigorosa al fantasticare sfrenato del racconto mitico e agli incantesimi della magia.
Qual è l’elemento che permette di accomunare comportamenti e credenze così disparati ? Più che in un preciso contenuto dottrinale esso va forse cercato in un atteggiamento mentale o interiore, in un particolare modo di porsi nei confronti del mondo, di Dio, della salvezza. Per lo gnostico esiste una contraddizione inconciliabile tra il mondo in cui vive e il Dio assolutamente trascendente. Il mondo è il prodotto di un conflitto all’interno del Pleroma (= pienezza) divino : l’uomo, la cui natura più profonda è divina, si trova intrappolato , irretito in questo mondo, al quale si sente completamente estraneo. La salvezza per lui consiste nel liberarsi dai vincoli che lo legano alla materia, al corpo, al mondo umano. Questa liberazione egli ottiene quando prende coscienza della propria identità divina. È questa la “gnosi”, conoscenza di sé e conoscenza di Dio, che sono poi la stessa cosa. Siccome l’uomo è prigioniero del corpo e della materia, reso cieco, come stordito, ubriaco dal mondo, ha bisogno di una chiamata che venga dal di fuori e lo risvegli, facendogli prendere coscienza della sua vera natura. Il compito di portare questa chiamata nella prigione del mondo è affidata ad un Rivelatore. Il contenuto della chiamata è semplicemente che l’uomo appartiene a Dio ed è estraneo al mondo. Colui che porta in sé la scintilla divina è in grado di ascoltare questa chiamata e di conoscere la propria natura; attraverso questa conoscenza (la gnosi) , egli ottiene la liberazione dai vincoli della materia che lo rendevano schiavo. È precisamente questa conoscenza che distingue lo gnostico dalla massa degli altri uomini che rimangono nell’ignoranza, e ne fa un privilegiato.
Oltre a questo che è il messaggio essenziale dello gnosticismo (risposta alla domanda: chi sono io?), tutti gli sviluppi dottrinali particolari dei vari sistemi sono fondamentalmente ordinati ad aiutare l’adepto a rispondere a queste domande: da dove vengo? Come mai mi trovo qui? Come posso ritornare al mio luogo di origine? Per questo le dottrine gnostiche sviluppano con ricchezza di particolari il racconto delle vicende del mondo divino, del conflitto in esso prodottosi che ha dato origine al mondo materiale (teogonia e cosmogonia) e della via da percorrere per ritornare nel Pleroma originario.
In età ellenistica la concezione impersonale del potere divino sotto l’influsso di dottrine provenienti dall’oriente, tende a configurarsi come una sorta di energia cosmico-divina, che trova le proprie rappresentazioni tanto nelle forme classiche delle divinità tradizionali quanto nelle sfere esoteriche della magia e dell’astrologia. L’individuo dà nuova forma all’antica consapevolezza già propria dei culti misterici; c’è nell’uomo qualcosa di divino che bisogna “liberare“ da ciò che offusca la sua immagine più pura.
L’interrogativo più drammatico che l’uomo si pone è il seguente: “Se Dio è buono da dove viene il male?“ Si tratta di una domanda esistenziale propria dell’uomo in quanto tale, a cui ogni forma di sapienza filosofica o religiosa ha cercato di dare, in modo più o meno diretto, una risposta.
Per la mentalità gnostica il problema diventa centrale, vero propulsore del suo immaginario, a patto di assumere tale problema nella sua forma più “drammatica“. Di fronte al male lo gnosticismo opera una ribellione radicale e si mostra incapace sia di inquadrarlo come una forma di “non- essere“ all’interno di un cosmo sostanzialmente buono ( come farà invece Plotino ), sia di attribuirsene la responsabilità attraverso il peccato per poi accettarlo come mezzo di redenzione (secondo ciò che è proprio della dottrina cristiana).
Ecco le risposte. Possono essere schematicamente distinte in due grandi gruppi:
quelle che prendono le mosse da un dualismo originario e radicale (come nel caso del manicheismo, o di movimenti di area culturale iranica); quelle che prendono le mosse da una caduta di un dio minore (come nel caso della gnosi di area culturale siro-egiziana).
Nel primo caso, semplificando i parametri concettuali del discorso, potremmo dire che Dio, la Luce suprema, è assolutamente buono, ma non è onnipotente (o quanto meno non lo è immediatamente) visto che deve ingaggiare una lotta titanica con un principio malvagio primordiale (la Tenebra). Nel secondo caso si tende a moltiplicare indefinitamente le personificazioni intermedie fra il Dio Supremo (che sarà, per esempio, Abisso, ineffabile e in conoscibile) e quell’entità generale inferiore che, colpevolmente attratta dai regni inferiori per i motivi più svariati, si troverà a decadere dalla sua dignità originaria. Tale “ caduta “ è stabilita prima del cosmo e una delle sue conseguenze è la nascita del cosmo stesso con la correlativa “ prigionia “delle anime divine del mondo.
Come si vede, sullo sfondo c’è un pessimismo radicale nei confronti del mondo, pensato come assolutamente cattivo e corrotto. Tutto ciò potrebbe apparire strano se si pensa che è proprio dall’evidenza dell’ordine e dell’armonia del cosmo che ha preso le mosse tutto il cammino dello sforzo filosofico fin dai “ presocratici “. In un certo senso, tra tutti gli elementi di varia origine e natura che confluiscono in tale concezione, il problema a cui si vuole dare risposta è il problema del male: si vuole scaricare Dio dalla responsabilità del male e, conseguentemente, si immaginano degli intermediari tra il Bene supremo (il Dio sommamente buono) e la materia o il Mondo.
Nella sua forma cristiana, lo gnosticismo assunse alcuni tratti caratteristici, desunti in particolare dalla tradizione biblica, vetero e neo-testamentaria. Il mondo materiale, connotato negativamente, non può essere stato creato dal Dio trascendente; è invece l’opera di un demiurgo, generalmente identificato con il Dio dell’AT; questo comporta una svalutazione dell’economia veterotestamentaria. Inoltre, la figura del Rivelatore, che viene dal mondo a portare la gnosi, è in genere impersonata da Cristo; ma poichè la salvezza gnostica non è mai salvezza di tutto l’uomo, ma soltanto della parte divina che è in lui ( per il corpo e la materia non c’è salvezza possibile ), così anche il Cristo, venendo nel mondo, non ha assunto tutto l’uomo : la sua incarnazione e la sua passione sono soltanto apparenti (docetismo). In questa forma, lo gnosticismo costituì il primo grande pericolo con il quale la chiesa dei primi secoli si sia dovuta confrontare. I padri della chiesa posero tutto il loro impegno per cercare di confutarne le dottrine, contrapponendo alla loro interpretazione delle Scritture l’autorità dell’interpretazione tradizionale di cui era depositaria la chiesa e che era stata tramandata pubblicamente attraverso una catena ininterrotta di tradenti che risaliva fino agli apostoli, e insistendo sull’identità del Creatore con il Dio supremo, sulla bontà della creazione e del mondo materiale, sulla realtà dell’incarnazione e della passione di Gesù.
Le risposte dei "filosofi" cristiani
Tra i primi, ed il meglio informato è Ireneo. Ireneo, come Giustino, è un orientale, originario dell’Asia minore (dove si presume sia nato verso il 130). Ma di lui si ignorano le circostanze che l’hanno condotto in occidente. A Lione, dove sarà vescovo, Ireneo smaschera, controbatte, opponendo alla falsa gnosi la sua fedeltà, non soltanto rispettosa ma entusiasta, alla tradizione della Chiesa.
Per lui la Chiesa è la salvaguardia della vera fede. All’esoterismo gnostico, che pretende di fondare le sue conoscenze fantasiose su tradizioni segrete, Ireneo è il primo ad opporre formalmente la tradizione pubblica, verificabile da tutti, che ad essi ricollega la Chiesa di vescovo in vescovo.
Quel che ad Ireneo sembra l’essenziale di questa fede della Chiesa in opposizione alle false “gnosi“, è quello che egli chiama, sulla base della lettera di san Paolo agli Efesini, “la ricapitolazione“.
Così come egli la intende, la parola designa insieme la ripresa di tutta la storia umana deviata nell’ “economia“ salutare del Cristo, e la salvezza e la riconciliazione di ogni cosa in Lui. La “ricapitolazione“ si oppone dunque ad entrambi gli errori secondo i quali il Dio, Padre del Cristo, non sarebbe il creatore di tutte le cose , visibili ed invisibili, corporali e spirituali, e inoltre il Verbo non si sarebbe incarnato se non in apparenza. I due termini del discorso sono:
I Il dono continuo di Dio, dalla creazione alla gloria (Deus facit, Deus bene facit).
“Come dunque sarai Dio, quando non sei ancora stato fatto uomo? Come sarai perfetto, quando sei stato appena creato? Come sarai immortale, quando in una natura mortale, non hai obbedito al tuo Creatore? Bisogna che tu prima ti mantenga nella tua condizione di uomo, e solo dopo abbia parte alla gloria di Dio. Giacchè non sei tu a far Dio, ma è Dio che ti fa. Se dunque sei opera di Dio, attendi la mano del tuo artefice, che a tempo opportuno tutto fa: a tempo opportuno rispetto a te, che vieni fatto. Presentagli un cuore tenero e docile, e conserva la forma che ti ha dato l’artefice…” (Contro le eresie, IV, 39, 2)
L’opera di Dio nella storia della salvezza consiste in un “ moltiplicare “ la grazia che da lui viene in una progressiva formazione del genere umano attraverso l’ordine creato, la legge, i profeti .
II La continua crescita dell’uomo verso Dio (homo fit – bene fit homini). È proprio la natura creaturale che motiva il divenire dell’uomo, e che impone lo spiegarsi dall’economia divina secondo i suoi diversi momenti, con l’intervento delle tre persone divine.
Contro il dualismo degli gnostici, Ireneo affronta il tema della bontà della carne. Inoltre, egli insiste sul concetto che l’uomo deve crescere nella sottomissione a Dio attraverso la libera scelta del bene, lottando contro il male. Dopo tutto, l’uomo è artefice del suo destino.
Ireneo trova il fondamento dell’essere cristiano nella regola di verità, ricevuta con il battesimo (cfr. Dem. 6). L’uomo è stato fatto dalle mani di Dio, che ha preso la terra più pura, la terra vergine, non lavorata da alcuno (cfr. ibid. 11).
Ma, contrariamente al tricotomismo platonico, egli afferma l’uguaglianza di tutti gli uomini. L’uomo può divenire immortale, divino, spirituale, ricevendo lo Spirito di Dio (cfr. Adv. Haer. III, 22, 1; 20, 2; V, 6,1; 8,1-3; 16,2), perché è la grazia di Dio che deifica l’uomo. Ma l’uomo, da parte sua, deve fare la volontà di Dio, se vuole partecipare alla vita trinitaria. Se l’uomo Adamo fu elevato allo stato soprannaturale, Cristo ha fatto di più: ci ha reso figli. Ha fatto ciò che l’uomo non poteva fare:
“Come potrebbe l’uomo andare verso Dio, se Dio non fosse venuto all’uomo?... E questa è la ragione per cui il Verbo di Dio si è fatto carne e il Figlio dell’Uomo, affinché l’uomo entri in comunione con il Verbo di Dio e, ricevendo l’adozione, diventi Figlio di Dio “ (Adv. Haer, IV, 33, 4; III, 19, 1).
Ma la fortezza per l’uomo è anche l’Eucaristia:
“…siamo nutriti per mezzo del creato…il calice, tratto dal creato, egli lo ha dichiarato suo proprio sangue, mediante il quale il nostro sangue si fortifica e il pane, tratto dal creato, lo ha proclamato suo proprio corpo, mediante il quale si fortificano i nostri corpi “ (Ibid. V, 2,2).
Per Ireneo è importante il dono della carità (agápe), che è più preziosa delle scienze e della profezia: importante è relazionarsi a Dio.
“La visione di Dio è la vita dell’uomo e la vita dell’uomo è la gloria di Dio“ (Ibid. V, 2, 2)
Vivere è partecipare alla vita di Dio, cercare di conoscerlo, essere rischiarato dalla sua luce:
“Dio è lui stesso la vita di quelli che partecipano di lui“ (Ibid. V, 7,1).
Se la ragione è incapace di afferrare Dio, l’amore può intenderlo ed avere esperienza della sua presenza. Secondo la Scrittura, è impossibile vedere Dio e restare in vita, ma Dio si mostra a coloro che l’amano, quando vuole. Allo stesso modo, quelli che vedono la luce sono nella luce e partecipano al suo splendore: così quelli che vedono Dio, partecipano alla Vita.
È il modello della creazione, che l’uomo deve imitare per ritornare al Padre da cui si è allontanato: questi progressi si compiono per la grazia dello Spirito Santo, poiché lo Spirito assorbe la debolezza della carne (cfr. Ibid. V,12,4).
L’uomo che si apre allo Spirito, non è più carnale, ma diviene spirituale e perfetto. Il punto culminante è divenire Dio, con un processo che continua oltre la morte, che si perfeziona dopo, perché la morte non è che una tappa nel divenire perfetti. Niente sfugge a questa legge dell’ascensione ( per gli gnostici è discesa )verso Dio. Nella nuova economia, Cristo ricapitola, riassume tutta la creazione, comunicandole ciò che aveva perduto per colpa di Adamo, riprende tutto sul suo conto, anche la nascita del primo uomo. Sulle orme di S. Paolo (Ef 1,9; Rm 8), Ireneo concepisce la dottrina della “ricapitolazione“. In essa elabora la storia della salvezza, ravvisandola nel mutuo adattamento da parte di Dio e dell’uomo, del progresso e dell’educazione. Egli presenta l’Incarnazione, in quanto essa riassume e compie tutta la storia precedente dell’uomo, l’istituzione di Cristo come capo di tutto l’universo nel fatto che Cristo e Maria, con la loro ubbidienza hanno riparato la disubbidienza di Adamo ed Eva.
Tutta la creazione si rinnova per mezzo di Cristo: il nuovo Adamo restaura il primo. L’itinerario che segue porta alla dimensione trinitaria: per mezzo dello Spirito, l’uomo contempla il Figlio e, attraverso il Figlio, il Padre. Il senso trinitario della dottrina sottolinea l’orientamento costante verso la Trinità che sarà caro ai mistici di tutti i tempi.
“Al disopra di tutto, il Padre, ed è lui il capo del Cristo. Attraverso tutto, il Verbo, ed è lui il capo della Chiesa. In tutto, lo Spirito, ed è lui l’acqua data dal Signore a coloro che credono in lui, lo amano, e sanno che c’è solo un Dio Padre, che è al di sopra di tutto, attraverso tutto e in tutto”. (Ibid. V, 18,2).
In questo suo divenire continuo, l’uomo ha per compagne, non solo il Padre, ma anche le mani di Dio, il Verbo e la Sapienza. E proprio queste mani, che lo hanno plasmato fino dall’inizio, a immagine e somiglianza del Creatore, lo collocheranno nuovamente nel paradosso, come hanno fatto per Elia ed Enoch.
La gnosi di Ireneo, in effetti, come quella di san Paolo, di san Giovanni, e prima di loro dall’apocalittica giudaica, crede incrollabilmente in un solo Dio, creatore di tutte le cose e che solo può esserne il Salvatore.
Ma, precisamente, essi prendono tutti talmente sul serio la creazione che le volontà libere e il mistero del loro gioco nelle mani del Creatore (di cui parla spesso Ireneo, e che sono per lui il Figlio e lo Spirito) vengono da loro interamente rispettati. La redenzione, per la “gnosi “ ortodossa, non sarà dunque una semplice liberazione di puri spiriti rinchiusi per un errore originario in un corpo e in un mondo essi stessi non salvabili. Essa sarà un conflitto, una vittoria riportata con un’altra lotta da parte del Creatore, che viene a lottare con e nella sua creatura contro le potenze di inimicizia che la disobbedienza di questa ha essa stessa scatenato. Così, tutto sarà salvato, la materia come lo spirito, di quello che la lotta e la vittoria divina faranno proprio. Ma al contrario si perderà lo spirito stesso che persisterà fino alla fine di questa colpa originale, la quale non è soltanto un errore, ma una ribellione. Una volta visto chiaramente tutto ciò che l’opera di Ireneo mette in luce nei confronti dello gnosticismo eretico, si distingue forse meglio il malinteso fondamentale di certi tentativi moderni intrapresi per “demitizzare“ il cristianesimo primitivo (es. Bultmann).
Dopo Ireneo ascoltiamo il contributo di Clemente Alessandrino. Ad Alessandria la difficoltà di conciliare con il cristianesimo la cultura ellenistica fu particolarmente avvertita. Clemente affrontò decisamente questo problema e lo risolse con uguale energia, in senso favorevole. Egli si pose sulle orme di Giustino, ma con visioni ancora più vaste e concilianti, specialmente negli Stromata: anche ai filosofi pagani fu concessa la luce di molte verità, in vista, e come remota preparazione alla verità totale portata dal Cristo. Egli arriva ad apprezzare la filosofia pagana quasi come un terzo testamento paragonabile alla Legge degli ebrei, sia pure di un gradino inferiore, per il quale si accede alla filosofia secondo Cristo (Strom. , 6,8,67,1).
La rivelazione è la grande luce che Dio ha sparso sul mondo. Ma anche la filosofia può rivelare molte verità, le quali, appunto perché verità, provengono dalla stessa e unica sorgente. Clemente, dunque, è sullo stesso piano di Giustino. La sola differenza sta in una maggiore insistenza, da parte di Clemente, nel ritenere come compito della filosofia pagana quello di costituire un fattore preparatorio a comprendere l’integrità della Rivelazione cristiana. Ma c’è di più. Nelle sue opere Clemente si propone come fine essenziale il progresso dell’anima che si eleva per gradi, dalla prima giustizia ricevuta nel battesimo, fino all’ultima perfezione considerata nella conoscenza e nella contemplazione di Dio. Questa perfezione egli la chiama “gnosi“. Ma qui sta la sua differenza con gli gnostici: essi proponevano la “gnosi“ come innata, e riservata a pochi privilegiati. Clemente nega questa teoria ed afferma che essa è frutto di una assidua applicazione mentale; è una lenta conquista, e occorre alimentarla e accrescerla con un esercizio incessante.
È tuttavia necessario rilevare che Clemente non sempre sviluppa questa dottrina in modo costante e coerente. Talvolta sembra limitare la perfezione della “gnosi“ soltanto a coloro che se ne rendono capaci. Fatte queste premesse, rimane la constatazione dell’interdipendenza che egli ammette fra fede e gnosi:
“La fede è, per così dire, una breve e compendiosa conoscenza degli elementi necessari (per la salvezza). La gnosi è ferma e stabile dimostrazione degli elementi derivanti dalla fede: essa si costruisce attraverso l’insegnamento del Signore, e conduce ad una scienza infallibile e ad una comprensione perfetta“ ( Strom.,7, 10 ) = Teologia.
Nel tentativo operato da Clemente di conciliare la filosofia con la Rivelazione si ha l’inaugurazione della cosiddetta gnosi cristiana,in rapporto stretto con l’allegorismo introdotto nell’interpretazione della Scrittura: è questa, del resto, un’esigenza affiorata interamente in funzione della prima e che tradisce una diretta dipendenza da Filone e dalle correnti giudeo-elleniste. Per Clemente la filosofia deve mettersi al servizio dell’intelligenza della Scrittura: essa aiuta a precisare il contenuto della fede e induce lo studioso a passare dalla semplice aderenza ai dogmi della fede alla conoscenza (scientifica) della fede stessa. Il punto di partenza è offerto dai fatti presentati dalla Scrittura e dalle verità rivelate. È qui che deve intervenire la ricerca personale per giungere ad una conoscenza ( gnosi ) superiore. Ogni credente, grazie ad essa, può divenire un sapiente, uno “ gnostico cristiano “(Strom., 1, 99 1 ss; Strom6, 18, 114). È vero che tutti i credenti possono raggiungere la salvezza, ma la conoscenza delle verità della fede, raggiunta attraverso la penetrazione più profonda delle stesse verità, operata dall’esercizio della mente, rende l’uomo e il credente più perfetto. Si può dire che Clemente è riuscito a porre i fondamenti del metodo teologico.
Uno dei capisaldi della dottrina di Clemente è la natura e la funzione del Verbo (Lógos). Ogni germe di verità, ogni rivelazione atta ad illuminare la mente dell’uomo, viene da Lui. In ogni essere creato non esiste scienza se non per mezzo suo.
“È Lui che fin dall’origine, che fin dalla prima creazione del mondo, ha istruito ( l’uomo ) in molti modi e sotto molte forme, ed è a Lui che si deve la perfezione (del sapere)“ (Strom., 6, 7, 57) .
È chiaro che Clemente riprende anche qui il discorso di Giustino, apportandovi soltanto più insistenza e più ardore. Egli sottolinea un aspetto singolare dell’insegnamento del Cristo: il maestro degli uomini più per la sua natura di Verbo divino e di sorgente di verità attraverso la luce, illuminante direttamente la mente dell’uomo, che non per l’azione esercitata da Lui attraverso l’insegnamento del vangelo, come Verbo incarnato.
In opposizione alle pretese degli gnostici egli insiste su due temi fondamentali: la Chiesa è nata prima delle eresie, ed è nata sotto il segno di una inscindibile unità. L’opera delle eresie è diretta alla divisionee alla disgregazione, per questo Clemente non esita a dichiarare che uno dei maggiori ostacoli alla conversione dei pagani e degli ebrei è l’esistenza delle conventicole eretiche.
L’ideale del ”perfetto gnostico"
Assistiamo ai risultati di un sapiente processo di inculturazione. È sufficiente leggere la definizione della gnosi che Clemente ha dato nel secondo libro degli Stromati
“Ecco le tre note che contraddistinguono il nostro gnostico: in primo luogo la contemplazione, poi l’adempimento dei precetti, infine l’istruzionedei buoni. Quando si riscontrano queste qualità in un uomo, egli è uno gnostico perfetto; ma se una di esse viene a mancare, la sua gnosi è manchevole” (Strom., 2, 10, 46).
Ecco i tre elementi di questa gnosi.
“La gnosi“, ci dice il VI libro degli Stromati, “è il principio e l’autore (demiurgós) di ogni azione conforme al Logos (Logiké)”.Trasferendo questa nozione del tutto biblica in termini stoici, alla maniera sia di san Paolo che di Filone, il IV libro la definisce come un’ ”energia” che è la purificazione dell’egemonikón dell’anima, ossia del suo potere di giudicare e di scegliere. La gnosi in quanto tale è vista da Clemente come il dono di Dio: il dono del Cristo per eccellenza. Non la si trova, ma piuttosto si è trovati da essa (Strom., 1, 32, 4).
Bisogna che noi leggiamo le Scritture nella Tradizione,che, per lui, non è tanto una realtà estranea alle Scritture ma la loro presentazione naturale fatta dalla Chiesa: infatti “ gli insegnamenti che ci hanno trasmesso i beati apostoli e i maestri sono in accordo con le parole ispirate “, in quanto essi ci hanno trasmesso quelle parole stesse (Strom., 4, 134, 4). In effetti, le Scritture restano lettera morta se noi non abbiamo per leggerle quello che lui chiama il “canone ecclesiastico“. Con questo si intende una regola vivente di interpretazione di cui Clemente ha data questa ammirabile definizione:
“La sinfonia della legge e dei profeti nell’alleanza che ci è stata trasmessa con l’apparizione ( parusía ) del Signore “ (Strom., 7, 95, 3).
Tutto ciò coincide con la descrizione della gnosi che ci ha dato Ireneo.
Una “ filosofia cristiana “
Per Clemente, la filosofia greca, o più esattamente il sapere enciclopedico dell’epoca, costituisce come una propedeutica, se non necessaria almeno molto utile, alla gnosi cristiana. Ecco quello che egli dice a riguardo nel libro VI degli Stromati:
“Lo gnostico deve approfittare delle scienze profane, come di esercizi preliminari dai quali egli può trarre profitto, sia per insegnare la verità con esattezza e con sicurezza sia per confutare le malvagie teorie, che tentano d’abbatterla. Egli perciò dovrà conoscere quelle discipline che formano il cerchio delle cognizioni generali ( tà egkúklia) e guidano all’apprendimento della filosofia ( greca ). Di questa scienza, della quale i sostenitori delle eresie si valgono a fin di male, lo gnostico deve approfittare a fin di bene “ ( Strom., 6, 10, 80-83 ).
Tutto questo ci conduce verso un apice della gnosi che pare decisamente mistico, se si dà a questa parola il senso di una visione divina, che trasforma l’uomo ad immagine di quello che egli vede. Il vero gnostico è chiamato a “conoscere Dio“: gignóskein, o epignónai, a “vedere Dio“, a “possederlo“: choreïn.
Sempre a proposito dell’apice della vita gnostica, dell’assimilazione a Dio, Clemente introdurrà nel linguaggio cristiano il termine apátheia. A partire dai Cappadoci e da Evagrio il Pontico, questo termine sarà ripreso dalla dotta spiritualità monastica dove rivestirà un ruolo notevole. In Clemente il termine significa un dominio conquistato, mediante la grazia alla quale si abbandona la nostra libertà, su tutto quello che, in noi, si oppone all’irraggiamento della carità. L’apátheia dunque, lungi dal rendere lo gnostico insensibile alla agápê cristiana, ne è in verità lo splendore vittorioso.
Scrive Clemente:
“Il vero gnostico che ha preso l’abitudine alla bontà, agisce bene piuttosto che parlare bene; domanda la compassione per i peccati dei suoi fratelli; prega perché i suoi intimi confessino i loro peccati e si convertano, desidera rendere partecipi dei suoi beni i suoi amici più cari e tali sono tutti i suoi amici. Facendo così germogliare i semi riposti in lui, secondo la coltivazione che il Signore ha disposto, rimane senza peccato; è padrone di se stesso e vive con lo spirito nei cori dei santi, anche se è ancora trattenuto sulla terra. Un tale uomo, che agisce e che parla in tal modo di giorno e di notte seguendo i comandamenti del Signore, arriva alla gioia perfetta, non soltanto all’alba quando si leva e a metà del giorno, ma anche quando cammina, quando si corica, quando si veste e si sveste. Egli istruisce il figlio suo, se gli nasce un figlio; non può separarsi dalla legge e dalla speranza; rende continuamente grazie a Dio, è paziente in ogni avversità: “ Il Signore, egli dice, ha dato, il Signore ha tolto”. Tale era Giobbe che accettava la perdita dei beni esteriori, fino a quella della salute corporale, dice la Scrittura, giusto, santo, lontano da ogni malizia”. La santità significa qui la giustizia riguardo a Dio secondo tutte le disposizioni divine, ed è per aver conosciuto questa giustizia che egli era gnostico”. ( Strom. , 7, 12, 80).
Clemente ha l’arte di condurci verso le altezze di una spiritualità pura ed esigente. Non v’è dubbio che la sua opera, specialmente la sua descrizione dello gnostico ideale, abbia aperto le vie alla spiritualità che sarà ben presto chiamata mistica più direttamente di qualunque altra.
Qualche conclusione
La difficoltà di rapportarsi con il mondo dei nuovi movimenti religiosi ( in particolare la New Age), da parte del cristiano, si lega sia a problemi di ordine conoscitivo ( è difficile identificare bene un fenomeno dai confini confusi e sfuggenti ), sia a problemi di origine relazionale ( l’atteggiamento ambiguo nei confronti delle altre religioni in genere e di quella cristiana in particolare è un esempio significativo di tale difficoltà ), ma tutto questo non deve scoraggiare coloro che, armati di santa pazienza e di buona volontà, desiderano portare un proprio contributo alle difficili relazioni con il variegato mondo dei vari nuovi movimenti religiosi. Noi, oggi, pur essendo dei nani, sulle spalle dei giganti, i Padri, abbiamo orizzonti più vasti. Le lezioni che ci vengono da questi giganti possono essere:
È necessario conoscere meglio i confini attraverso il contributo di studi seri e capaci di offrire al lettore quegli strumenti critici che i diretti interessati si guardano bene dal mettergli a disposizione. Operare discernimento per individuare i modi in cui i nuovi fenomeni religiosi tentano con scaltrezza di diffondersi. Tentare di instaurare un dialogo con quanti si lasciano avvicinare ( e generalmente manca una certa disponibilità iniziale ), proponendo loro con semplicità e chiarezza la “novità” del messaggio cristiano evitando di lasciarsi “asfissiare” dietro una cortina “mitopoietica” che rischia di renderlo quasi irriconoscibile.
La prima eresia (Lorenzo Dattrino)
La prima eresia
di Lorenzo Dattrino

Il confronto, il dialogo, l’apertura ai fenomeni culturali è stata una coraggiosa iniziativa di uomini come Giustino. Ora, all’interno stesso del cristianesimo, sorgono varie correnti di pensiero (gnosticismo, marcionismo, montanismo) che minacciano la genuinità e l’unità della fede. Di fronte a queste correnti eterodosse ecco le reazioni dei pastori i quali condannanol’azione positiva: illuminare i fedeli intorno ai capisaldi della vera fede trasmessa dalla Tradizione. Tra questi teologi illuminati ricordiamo Ireneo, vescovo di Lione, il quale compone una trattazione completa (anche se non organica) della dottrina cristiana, una sorta di “catechismo“ per istruire coloro che si preparavano a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana: Adversus Haereses (Contro le eresie). La fragile “barca di Pietro“ rischia di cozzare contro quell’iceberg, lo gnosticismo, e di affondare. Ma non fu così! quelli che seminano zizzania. Però le condanne non bastano. Determinante risulta soprattutto
Per capire qualche cosa del complesso fenomeno culturale della gnosi bisogna saper distinguere fra “gnosticismo“ e “gnosi“. Col primo termine s’intende ordinariamente l’eresia che nei secoli II e III tentò di sostituire alla semplice fede una conoscenza del divino più elevata e perfetta, accessibile soltanto a pochi. Ne risultò un complesso di sistemi eterodossi professanti un “dualismo radicale“ fra il mondo degli spiriti e il mondo dei corpi. Gli gnostici fecero della conoscenza la condizione ineliminabile della salvezza. Gnosi, infatti, è la conoscenza dei misteri divini riservata ad una élite.
Ci fu una gnosi eterodossa e una gnosi cristiana.
La prima, la gnosi dello gnosticismo, era quella che implicava l’idea dell’identità del conoscente (lo gnostico ), del patrimonio conosciuto e del mezzo con cui si conosce ( la gnosi cioè come facoltà divina implicita, che deve essere risvegliata e attuata ). La gnosi cristiana invece comporta la conoscenza di Dio e dei suoi misteri fondata sulla fede e sulla tradizione della Chiesa, come pure dell’interpretazione spirituale della Scrittura, con la tendenza a distinguersi dalla interpretazione letterale della Scrittura, propria del semplice fedele. La gnosi cristiana avrà il suo massimo sviluppo e la sua sistemazione nel III secolo, soprattutto con Clemente di Alessandria e Origene.
Alla base della problematica gnostica, come postulato iniziale di tutto il sistema, c’è il dualismo, l’opposizione tra Dio e la materia, tra il divino e l’antidivino. Il silenzio dei testi gnostici riguardo alla Chiesa è quasi totale. Il loro ineresse è rivolto altrove. Preoccupati del Dio ignoto, e non di Colui che ne ha rivelato la volontà, gli gnostici preferiscono l’antropologia all’ecclesiologia. È questa anche una ragione del loro abbandono dell’Antico Testamento e della loro allegorizzazione del Nuovo. Anche se i diversi sistemi gnostici non costituiscono un blocco e un’entità indivisibile, spesso fonti o scuole, battezzate con nomi diversi, rappresentano una medesima ideologia.
Se lo gnosticismo ebbe il suo focolaio iniziale in qualche remota provincia dell’Asia Minore, ben presto si estese nei maggiori centri dell’impero, ad Alessandria in particolare, e poi a Roma. Il primo di questi maestri fu Basilide, che insegnò ad Alessandria, e visse al tempo di Adriano e di Antonino Pio, tra il 120 e il 160. Il problema che sta alla base delle sue ricerche è l’origine del male: “Donde viene il male e come è nato?“
Tutte le speculazione di Basilide furono riprese e sviluppate da colui che fu ritenuto il teologo più influente del III secolo: Valentino. Venuto a Roma, vi trascorse una trentina d’anni (136-165). Egli prometteva una conoscenza superiore (gnosi), cioè la comprensione di ciò che la chiesa proponeva semplicemente come oggetto di fede. Era una promessa assai gradita agli stessi intellettuali cristiani di formazione ellenica, i quali avevano imparato da Platone che la fede è una forma imperfetta di conoscenza. Questa gnosi – per rimanere in ambiente cristiano – si presentava come interpretazione della Scrittura accettata dalle chiese. Ma tale interpretazione, accessibile peraltro solo a pochi, risultava in netto contrasto con ciò che si insegnava nella predicazione o si professava al momento della iniziazione. Eppure, a chi faceva rilevare questo contrasto, Valentino e i suoi seguaci rispondevano che potevano raggiungere quella gnosi, leggendo la Scrittura in base a un principio interpretativo che Gesù Cristo aveva rivelato solo ad alcuni, con l’impegno di trasmetterlo ad altri segretamente. Si appellavano cioè ad una tradizione segreta, che consentiva loro di discernere la verità superiore sotto il velo del linguaggio figurativo dei testi sacri, se non addirittura di decidere quali Scritture, tra quelle che circolavano nelle chiese, meritassero fiducia, e quali no!
Nasceva così la divisione netta tra semplici credenti, che comprendevano la Bibbia secondo la tradizione pubblica, e gnostici, i quali la intendevano alla luce della tradizione segreta: due categorie di fedeli, nettamente separate. Dalla Bibbia così interpretata, essi ricavavano un sistema di pensiero caratterizzato da un netto dualismo. Stabilivano una precisa separazione fra il mondo superiore e celeste, e il mondo inferiore e terrestre: il primo ha come origine sua il Dio supremo e incomprensibile, da cui procedono, scandendo di grado in grado via via che si allontanano da lui, alcune entità (gli eoni). Essi costituiscono il mondo della perfezione, il Pleroma.
Il termine designava la sfera cosmica mediatrice tra l’assoluta realtà del principio ideale e divino, e l’assoluta irrealtà o vuotezza della materia. Il Pleroma era costituito insomma dal complesso degli Eoni. Per gli gnostici questo mondo non è buono e, come tale, non è in grado di accogliere la salvezza portata da Cristo. In particolare, tutta la realtà materiale non ha valore, né Cristo l’ha fatta propria (l’Incarnazione è pura apparenza!); né ha alcun valore la carne umana e tutto l’agire che da essa dipende. In tal modo si svuota il valore della libertà umana e dell’agire morale.
Ed ora solo una parola, sia pur brevissima, sulla scoperta (1945) della biblioteca di scritti in lingua copta, rinvenuta nei pressi di Nag Hammadi, in Egitto. Essa comprende dodici codici per un totale di cinquantadue trattati . Molte ipotesi sono state avanzate sull’origine e sulla natura della biblioteca. La collezione può essere stata la biblioteca di un gruppo o di una setta di gnostici o anche di un solo gnostico; o può aver costituito la documentazione raccolta da un polemista o da un eresiologo a scopo di confutazione; o, più semplicemente può rappresentare ciò che resta di una biblioteca più ampia. Grazie a questa scoperta possiamo vedere che le notizie relative alla gnosi trasmesseci da Ireneo non sono notizie ad usum delfini, ma sono del tutto obiettive. Il vescovo di Lione espone, (toglie il velo) le tesi gnostiche per confutarle alla luce della realtà storica dell’Incarnazione del Logos.
La riflessione patristica sulla gnosi è per noi oggi un patrimonio non trascurabile.