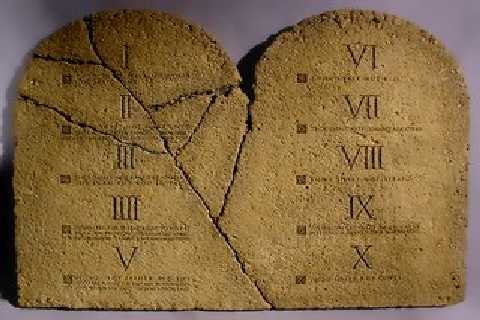La riflessione etica mira a valutare singoli comportamenti: per fare questo ha assoluto bisogno di un qualcosa su cui misurare il comportamento. Deve cioè render ragione del perché quel comportamento è moralmente accettabile o invece da rifiutare. Ogni proposizione etica - tu devi, tu non devi - richiede di esser giustificata: e prima di tutto è la coscienza del singolo agente che deve interrogarsi e rendere ragione a se stessa dell'accettabilità di un comportamento. Ma anche lo studioso - teologo o filosofo che sia - deve rendere ragione dei suoi pronunciamenti, in modo che il singolo agente possa agire per personale convinzione e non solo per obbedienza passiva a un ordine che gli viene dall'esterno. Per il singolo cristiano e per il teologo moralista la fonte prima di ogni valutazione è sicuramente la Parola di Dio. È però estremamente pericoloso prendere singoli precetti contenuti nella Scrittura staccandoli dal quadro generale dell'annuncio cristiano. Questo pericolo è presente in ogni capitolo della teologia morale - in ogni ambito delle scelte umane - e cercherò di farlo vedere in concreto analizzando la morale economica.
Significato del comandamento
Certamente il divieto di furto appartiene ai dieci comandamenti, provenienti dall'Antico Testamento e ripresi - in varie formulazioni - dal Nuovo Testamento. Ma qui si pongono subito due domande.
- Qual è il significato preciso e il valore normativo dell'espressione contenuta nel VII comandamento? La risposta non è affatto semplice sul piano strettamente esegetico (per il quale si può vedere l'importante studio di H. Schüngel-Straumann, Decalogo e dieci comandamenti, Paideia, Brescia 1977). Ma è ancor più complicata se si vuol trarre dall'espressione «non rubare» una norma precisa di comportamento. Se il furto vuol dire togliere a qualcuno il «suo», occorre definire che cosa sia il «suo», e cioè dare una qualche definizione di «proprietà». E la proprietà è una nozione sottoposta a continue variazioni sia nel tempo che nello spazio (il tema sarà discusso nel cap. 4). Variando la nozione di proprietà varia dunque anche quella di furto.
- Nella Scrittura il divieto di furto è l'insegnamento centrale in materia di morale economica? Nella tradizione dei manuali di morale dal 1600 fino alla metà del nostro secolo la risposta è indubbiamente sì. Ed è su questi manuali che hanno studiato morale tutti i preti sopra i 40/50 anni (e perciò anche tutti i vescovi e i cardinali). E invece sia nell'Antico, sia nel Nuovo Testamento, sia nei Padri, sia in Tommaso la risposta è no. Con le grandi encicliche sociali si hanno segni di ritorno a questa grande tradizione, ma in genere con frasi isolate, con espressioni talora contraddittorie all'interno di uno stesso documento, e di norma con tentativi di conciliare la dottrina dei manuali con la tradizione precedente. E in ogni caso le encicliche sociali hanno avuto scarsissimo influsso sui manuali e sull'insegnamento della teologia morale, tanto è vero che ancora oggi quasi ovunque esistono corsi di dottrina sociale cristiana autonomi rispetto ai corsi di teologia morale. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Sollicitudo rei socialis, ha detto esplicitamente che la dottrina sociale della Chiesa è parte della teologia morale: ma non sembra che abbia avuto molto successo, specialmente in molti che incensano pontefice ed enciclica a parole ma non lo seguono nei fatti.
Nel Nuovo Testamento sicuramente l'annuncio evangelico in materia economica non è centrato sul non rubare. Vi sono numerosissimi testi in cui tale annuncio appare ben più profondo: testi di autori diversi, scritti per destinatari e per tempi diversi ma tutti legati a un'unica logica di fondo, in cui il non rubare e il rispetto della proprietà altrui hanno solo il ruolo di applicazione concreta e quindi di modesto interesse teorico (ciò è vero in qualche modo anche per l'Antico Testamento, ma la discussione ci porterebbe troppo lontano).
Cercherò ora di richiamare l'attenzione del lettore su alcuni testi fra i tanti che hanno rilevanza per la morale economica (per qualunque scelta che il cristiano è chiamato a fare nell'ambito della vita economica), per poterne poi individuare la logica che li accomuna, e con essa tutta la profondità e la ricchezza dell'annuncio cristiano.
Il dovere di dare
«Voi farisei purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Stolti! Piuttosto date in elemosina quello che c'è dentro [oppure "sopra il piatto" oppure "quello che avete"], ed ecco, tutto sarà puro per voi» (Lc 11,39-41): è evidente la forza di queste parole. Non vi è purezza di fronte a Dio che sia legata a osservanze cultuali: solo se siamo pronti a dare quello che abbiamo siamo puri di fronte a Dio. La sacralizzazione della proprietà, tipica della nostra mentalità e degli ultimi secoli della cultura occidentale, è subito messa in questione. E non si tratta solo di dare il superfluo: in Lc 21 molti fanno offerte al tempio ma la povera vedova che dà solo due spiccioli «ha messo più di tutti. Tutti costoro infatti han deposto come offerta del loro superfluo, questa invece nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere». Prima dunque del dovere di non rubare vi è il dovere di dare, come condizione per presentarsi puri di fronte a Dio.
Luca racchiude nel capitolo 16, fra due parabole - l'amministratore infedele e il ricco epulone -, alcuni detti di straordinaria potenza. Commentando la parabola dell'amministratore infedele, Gesù introduce il tema della ricchezza con due contrapposizioni: «ricchezza iniqua» e «ricchezza vera», «ricchezza altrui» e «ricchezza vostra». Per noi dunque, seguaci di Gesù, la ricchezza-denaro (o possesso di cose) non è ricchezza vera, non è ricchezza che ci interessa: non è la «nostra» ricchezza. E segue subito il detto famoso «nessun servo può servire a due padroni», ribadendo che Dio e le ricchezze sono padroni alternativi. Potremmo dire: per il cristiano le ricchezze non sono un bene in sé desiderabile. Solo Dio è oggetto degno della nostra ricerca e del nostro desiderio. Vengono subito in mente altri passaggi di grande rilievo: il ricco stolto, che accumula tesori sulla terra invece di prepararsi tesori in cielo (Lc 12,16-21), oppure il «Padre nostro», in cui si deve chiedere a Dio solo il pane per l'oggi, oppure il discorso sull'abbandono alla Provvidenza di Dio (Mt 6,25-34), oppure le parabole del tesoro. Matteo conclude: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato per giunta». Una sola cosa dunque ci deve interessare sul serio, ed è meritevole dei nostri sforzi: Dio e la venuta del Regno. Il resto (le ricchezze) non dobbiamo cercarlo, ma ci sarà dato. La tensione morale verso Dio e il suo progetto per l'umanità deve esser tale da rendere senza senso ogni ricerca di ricchezza come bene in sé. Ai farisei che lo irridono Gesù risponde: «Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio». Questa parola, nella sua durezza, sembra non abbia niente da dire alla morale economica: se io riduco tutto al dovere di non rubare e a qualche opera di carità, non vi è spazio per la condanna della ricerca ossessiva della massimizzazione del profitto, che è poi la logica di un sistema economico regolato primariamente dal mercato.
Vizi della ricchezza
San Paolo ha numerosi elenchi di vizi per i quali si è esclusi dal Regno. Tra questi appare sempre (salvo in un caso) il termine pleonexia, che indica sia l'avidità che l'avarizia: la ricerca di sempre maggiori ricchezze e la ripugnanza o il rifiuto di dare del proprio. Sembra strano che di tali elenchi la teologia morale si sia ricordata ossessivamente e solo dei vizi riguardanti la sessualità - e prendendosi molte libertà interpretative, tutte in senso rigorista - e abbia totalmente ignorato i vizi inerenti alla ricchezza. Eppure l'esclusione dall'amore del Padre - la massima condanna pensabile per un cristiano - anche per san Giovanni è legata alla «superbia della ricchezza» (1 Gv 2,15-16: la traduzione Cei «la superbia della vita» è errata, dato che qui bios ha indubbiamente il significato di ricchezze, così come poco dopo in 3,17).
I beni non sono valore in sé
Il vero problema morale posto dal Vangelo, che i Padri e Tommaso ben conoscono, non è il non rubare, ma è quale significato debbano avere i beni terreni nella vita cristiana, in quell'orizzonte di fede e in quei criteri di discernimento entro cui ogni scelta, economica o no, deve orientarsi. I beni terreni - le ricchezze, anche se modeste - non possono in alcun modo esser viste come valore in sé: cercare di aver di più solo perché è di più è una forma di idolatria, un peccato fra i più gravi. È il peccato di avidità. Tutte le scelte del cristiano devono essere dominate non dalla gioia dell'aver di più, ma dalla gioia dell'appartenere al Regno e di esserne costruttore all'interno della storia umana. Le ricchezze acquistano senso e valore solo come strumenti di sempre migliore attuazione del Regno, e solo a questo scopo possono essere cercate. San Paolo lavorava per guadagnare e così non essere di peso alla comunità che lo accoglieva. Per questo motivo possedere ricchezze non è necessariamente un male morale: a patto che questi beni siano considerati e usati come strumenti di servizio al prossimo. In altri termini: se io ho, ho per mettere quello che ho a servizio dei fratelli. Il rifiuto o la resistenza interiore a questa logica di condivisione è l'altro gravissimo peccato: il peccato di avarizia. E si badi bene: avarizia non è solo spilorceria nel fare elemosine. Il ricco che fa occasionalmente donazioni benevole al poverello, considerando il suo gesto una mirabile opera di carità, è ancora un avaro. Avarizia è ritenere le ricchezze possedute come proprie, e non come strumento che la Provvidenza ci offre per meglio servire il prossimo.
La logica dell'avidità
È questa, a mio giudizio, la parola che non passa, e che avrebbe dovuto e oggi più che mai dovrebbe esser di guida alla riflessione morale in materia economica; in due direzioni: nelle scelte personali del singolo agente e nelle scelte di intervento sulle complesse strutture che ormai dominano tutta l'economia planetaria. Nell'oggi della storia umana si assiste al dominio di una logica, che possiamo chiamare con una certa approssimazione «neoliberista», direttamente opposta all'annuncio cristiano. È una logica in cui avidità e avarizia - nel senso sopra descritto - sono virtù altamente rispettate e onorate, tanto che in pratica tutti accettiamo come irreversibile la tragica realtà di una famiglia umana in cui una piccola minoranza di ricchi (singoli e Paesi) si confronta con una larga maggioranza di poveri, e inevitabilmente la domina. Non abbiamo saputo annunciare e vivere il Vangelo, e siamo di fronte al fallimento del nostro annuncio morale in materia economica. Ma il Signore attende ancora la nostra conversione. Dobbiamo convertirci noi prima di pretendere che si convertano gli altri.
Enrico Chiavacci
(testo tratto dal libro di Enrico Chiavacci LEZIONI BREVI DI ETICA SOCIALE )
Si ringrazia Cittadella Editrice www.cittadellaeditrice.com per la gentile concessione della pubblicazione di questo testo di Enrico Chiavacci.