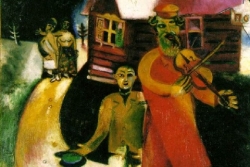Famiglia Giovani Anziani

Fausto Ferrari
Religioso Marista
Area Formazione ed Area Ecumene; Rubriche Dialoghi, Conoscere l'Ebraismo, Schegge, Input
La benedizione nuziale (Sante Babolin)
La benedizione nuziale
di Sante Babolin
Dopo la consacrazione del pane e del vino e la proclamazione del Padre nostro, «il sacerdote, rivolto verso la sposa e lo sposo, invoca su di loro la benedizione di Dio, che non si deve mai omettere. Gli sposi si avvicinano all’altare o, se opportuno, rimangono al loro posto e si mettono in ginocchio (…). Nei luoghi dove già esiste la consuetudine, o altrove con il permesso dell’Ordinario, si può fare a questo punto l’imposizione del velo sugli sposi (velazione), segno della comunione di vita che lo Spirito. avvolgendoli con la sua ombra, dona loro di vivere. Insieme, genitori e/o testimoni, terranno disteso il “velo sponsale” (bianco, con eventuale appropriato e sobrio ornamento) sul capo di entrambi gli sposi per tutta la durata della preghiera di benedizione» (RdM 84). Questo rito, che si deve sempre compiere, ci permette di comprendere il significato profondo della benedizione nuziale: è l’invocazione dello Spirito Santo, chiamato dalla Chiesa, a santificare l’unione degli sposi, così come ha santificato il pane e il vino che stanno sulla mensa, pronti per essere mangiati e bevuti. L’amore degli sposi, in tutte le sue espressioni, sarà santificato dall’ombra dello Spirito Santo e si convertirà in un cammino di continua e reciproca santificazione.
Simbolica del velo
Il velo copre e protegge; di qui i significati primari del segreto (o mistero) e dell’intimità (o riservatezza); inoltre un velo mosso segnala la presenza del vento, che non si può percepire se non si muove qualcosa.
Un episodio della vita di Mosè si presta a chiarire la funzione di nascondere che può assumere il velo:
«Quando Mosè ebbe finito di parlare agli Israeliti, si pose un velo sul viso. Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era stato ordinato. Gli Israeliti, guardando in faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso, fin quando fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore» (Es 34,33-35). Mosè mostra il viso raggiante e poi lo copre, perché non fosse visto quando la luce si sarebbe spenta.
In altri casi il velo assume la funzione di separare, di fissare un nuovo dentro e fuori. Così avviene nella tradizione monastica, in cui «prendere il velo» significa separarsi dal mondo, nel quale i comuni mortali continuano a vivere, e tenere lontano il mondo dalla nuova vita d’intimità con Dio, che si nutre di fede e di preghiera.
Infine nella liturgia eucaristica di rito bizantino, si muove dolcemente un velo, mentre si invoca lo Spirito Santo, per esprimere la sua venuta sul pane e sul vino; qui il velo significa l’azione santificatrice dello Spirito Santo che scende, sotto forma di vento come a Pentecoste, quando «all’improvviso venne dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove gli apostoli si trovavano» (At 2,2).
Da quanto detto sembra che il significato del velo abbia a che fare con una realtà segreta, sacra e spirituale. Perciò l’imposizione del veto, disteso sugli sposi dai genitori e dai testimoni, vuole esprimere quello che la benedizione nuziale conferisce, così come il velo mosso sui doni eucaristici manifesta l’invisibile venuta dello Spirito santificatore.
All’ombra dell’Altissimo
Nell’annunciazione l’angelo, rispondendo alla domanda di Maria «Come è possibile questo? Non conosco uomo», la rasserena dicendo: «lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo» (Lc 1,34-35). È questa benedizione di Dio Padre che attua in lei l’incarnazione di Dio; per questa benedizione il Figlio di Dio diventa uomo e Maria diventa la madre di Dio. Mi sembra che qualcosa di simile, per la benedizione della Chiesa, avviene sugli sposi, i quali, come dice la rubrica sopra citata, vengono avvolti dall’ombra dello Spirito Santo che dona loro di vivere una tale comunione di vita da renderli partecipi dell’amore trinitario e della potenza creatrice del Padre.
L’ombra è la shekinà biblica, segno visibile dell’invisibile presenza di Dio, come la «nube oscura» di giorno e la «nube luminosa» di notte, che guidava il popolo ebreo in cammino verso la terra promessa: «di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte» (Es 13, 22). il velo disteso sugli sposi, mentre il sacerdote invoca lo Spirito Santo su di loro, sarà per loro come shekina, benedizione efficace e permanente, che li guiderà nel cammino della loro vita condivisa. Però il velo che copre e protegge, ora che Cristo risorto è il Vivente seduto alla destra del Padre, richiama anche la sua signoria, quella potestà assoluta che Dio Padre gli ha conferito: «Cristo Gesù svuotò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre» (Fil 2,7-11).
Con queste immagini (velo, nube, signoria) viene tracciato anche il cammino dell’ascetica matrimoniale, della specifica spiritualità coniugale e familiare, in cui si alterneranno sempre tenebra e luce, umiliazione ed esaltazione, sofferenza e gioia; però la speranza cristiana suggerisce che il positivo prevarrà sempre sul negativo, che dopo la prova arriverà la gioia e che Dio Padre «non turberà mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande» (A. Manzoni, Promessi sposi, fine del cap. VIII). Tante cose potranno fare, a tante spiritualità si potranno orientare, però gli sposi potranno avere il filo costante che darà coerenza e solidità alla loro vita, soltanto se continueranno a confidare nella potestà del Cristo risorto.
Nella comunità dei credenti
L’indicazione di fare distendere il velo sponsale dai genitori degli sposi insieme con i testimoni suggerisce una partecipazione dell’assemblea, composta da parenti ed amici, alla benedizione impartita dal sacerdote.
Questo particolare suona come invito a parenti ed amici a rimanere accanto agli sposi, che iniziano il loro cammino verso una santità costitutivamente condivisa. Parenti ed amici sono i rappresentanti della Chiesa che si farà sempre presente per loro mezzo; e loro stessi potranno riattivare questa benedizione con l’affetto autentico, con la vera amicizia, con la preghiera, con il consiglio e l’aiuto fraterno.
D’altra parte è pure importante che gli sposi abbiano la consapevolezza che, come il loro Matrimonio è realizzato nella Chiesa, così anche la loro vita di coppia sarà costantemente e proficuamente santificata dal sacramento nella misura in cui resteranno uniti alla comunità cristiana, come tralcio alla vite, evitando l’isolamento, che potrebbe insidiare la loro unione e serenità, il cristiano, come ama ripetere spesso Benedetto XVI, non è mai solo; a maggior ragione, i coniugi cristiani e la famiglia.
La partecipazione alla Messa nella domenica e la preghiera in famiglia sono certamente un antidoto efficace contro il rischio dell’isolamento, perché sarà così pur facile superare i momenti di crisi che potranno presentarsi. Infine vorrei suggerire ai genitori di benedire i loro figli, con una piccola preghiera e un segno di croce in fronte, fin da piccoli: benedicendo i figli, riattiveranno la benedizione ricevuta nel giorno del loro matrimonio e, con i figli, ritorneranno sorto la shekinà di Cristo risorto e glorioso.
L’embrione è persona? Se sì, quando lo diventa? (Luigi Lorenzetti)
L’embrione è persona?
Se sì, quando lo diventa?
di Luigi Lorenzetti
Teologo moralista
In una conferenza il relatore distingueva tra essere umano e persona, che l’embrione non sarebbe una persona e non ci sarebbe concordia su quando lo diventa.
Giovanni C. Desio (Mi)
Non c’è distinzione tra essere umano e persona: ogni persona è un essere umano; ogni essere umano è persona. Il concetto “essere umano” indica appartenenza alla specie umana, che si collega ma anche si distingue da quella vegetale e da quella animale. Dire che l’embrione è un essere umano vuol dire che non è riducibile a un essere vegetale o animale. Ora, senza discriminazione alcuna, tutti coloro che appartengono alla specie umana sono persone, la cui caratteristica è la capacità di autocoscienza, razionalità e libertà.
Può accadere che la persona perda o non abbia ancora l’esercizio dell’autocoscienza e della libertà, ma non cessa di essere persona. L’embrione, il ritardato mentale grave, chi si trova in coma irreversibile non sono autocoscienti, razionali e liberi, ma non cessano di essere persone. Sarebbe come dire che un essere umano, in stato di sonno, non è persona. Il concetto di persona indica capacità costitutiva (ontologica) di consapevolezza e libertà che esiste anche se l’effettivo esercizio della medesima è impedito o non sviluppato.
Essere umano e persona sono sinonimi. Così, l’embrione umano può essere denominato con l’una o l’altra parola. Ma la questione non è questa. Il dibattito si riferisce a quando l’embrione diventa persona: lo è fin dall’inizio (fecondazione dell’ovulo) o lo diventa dopo? I filosofi antichi, in base alla visione dualista tra corpo e anima, ritenevano che l’anima subentrasse dopo che il corpo si era strutturato. Tale teoria è stata abbandonata, perché corpo e anima sono due dimensioni della stessa realtà: l’essere umano è «corpore et anima unus», dice il Vaticano II (Gaudium et spes 14).
La teoria dell’animazione successiva, tuttavia, si ripropone oggi sotto altra forma, con il sostenere che la persona passa da una condizione potenziale (antecedente al 14’ giorno) a quella reale o in atto. In altre parole, non sarebbe essere umano individuale dall’inizio, ma lo diverrebbe in fasi successive, con l’annidamento (dopo una settimana circa) o con la formazione della corteccia cerebrale (dopo un mese circa).
Le conoscenze biologiche (genetiche) evidenziano però che in tutto il processo generativo, a partire dalla fecondazione dell’ovulo, si verifica uno sviluppo unico, coordinato e progressivo. «La scienza medica ha mostrato», dice l’enciclica Evangelium vitae, «come dal primo istante si trova fissato il programma di ciò che sarà questo vivente: un uomo, questo uomo-individuo con le sue caratteristiche ben determinate. Fin dalla fecondazione è iniziata l’avventura di una vita umana» (n. 60).
In breve, fin dall’inizio, l’embrione è soggetto umano e non quasi-oggetto; è soggetto con potenzialità di sviluppo, non un soggetto potenziale; è soggetto autonomo e non parte della madre; è soggetto e, come ogni altro soggetto, ha diritto alla vita, ha valore finale e non strumentale, vale a dire va trattato sempre come fine e mai come mezzo. Rispettare l’essere umano o persona vuol dire rispettarlo in tutte le sue fasi.
DIZIONARIO MINIMO
DUALISMO - Quelle filosofie o culture che concepiscono l’uomo costituito di due realtà distinte: corpo e anima.
EVANGELIUM VITAE - La lettera enciclica di papa Giovanni Paolo II sul valore e l’inviolabilità della vita umana. È stata pubblicata il 25 marzo 1995.
GAUDIUM ET SPES - La costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, emanata dal Concilio Vaticano II il 7 dicembre del 1965.
ONTOLOGIA - La filosofia che prende in considerazione l’essere (òntos in greco), altrimenti detta metafisica (le cose che stanno oltre la natura).
Quale spiritualità per un altro mondo possibile?
Forum mondiale di teologia e liberazione
di Ugo Bozzoli

In che condizioni versa oggi la teologia della liberazione? 250 teologi, professionali e non, si sono incontrati a Nairobi per tastarle il polso e valutarne l’impatto che ha oggi sul mondo contemporaneo.
La superbia (Luciano Manicardi)
di Luciano Manicardi

«Inizio di ogni peccato è La superbia» (Siracide 10,15 secondo La Vulgata). Questo versetto biblico ha contribuito alla tradizione per cui La superbia è all’origine di ogni male ed è, almeno a partire da Gregorio Magno, al primo posto nella lista dei vizi capitali. Primo anche perché sentito come peccato contro Dio che echeggia il “voler diventare come Dio” presente nel racconto delle origini dell’umanità (Genesi 3,5).
La superbia si manifesta in quattro modi: «Quando si pensa che il bene derivi da noi stessi; quando si crede che, se ci viene dato dall’alto, è per i nostri meriti; quando ci si vanta di avere quello che non si ha; quando, disprezzando gli altri, si aspira ad apparire gli unici dotati di determinate qualità»(Gregorio Magno, Moralia XXXIII, 6, 16)
La musica, il sacro e il delirio (Sergio Quinzio)
Il Dio biblico sta nella domanda di redenzione, molto più che nelle eterne strutture dell'essere. Il contemplante riconoscimento della presenza dell'Armonia nel mondo è il sacro, la fede è la dolorosa consapevolezza dell'assenza dell'Armonia dal mondo.
I tamburi del profeta (Guido Ceronetti)
I tamburi del profeta
di Guido Ceronetti

Quando si fa più atroce la coscienza di essere in questo formicolante deserto cosi abbandonati, nazioni alla deriva, continenti oscurati, senza nessuno che guidi, che venga per salvare illuminando, mi ridà un poco di respiro pensare che Qualcuno, già domani, o nell'ora più nera, potrebbe anche sorgere, da questo fango stregato.
Chi? Un uomo, un inviato, un'incarnazione… Profeta, profetessa, santo, vergine, imperatore. Santa Giovanna, genio di guerra, miracolo di pace, eresiarca, Paracleto, Messia, non importa: purché venga dalla Luce, e la porti, e sia unto di olio sacro, uno che abbia la forza di rompere le prigioni della forza, di fermare l'empietà scientifica, e che porti la sua pietà per risuscitare la pietà: uno che sbaragli le leggi per stabilire la Legge, che ci prenda per mano, tutti, che a un cospicuo numero di carogne schiacci la testa e alle loro vittime la rialzi, che ci stacchi dal palo di questo rogo, che ci liberi da questa colossale trappola per topi che è la barbarie contemporanea.
Qualcuno che «non ciberà terra né peltro, / ma sapienza, amore et virtute » (Dante, Inf. I: anche lui, povero veggente angosciato, era in attesa di una Venuta) e per il quale valga in senso assoluto il dilexisti iustitiam et odisti iniqietatem (salmo 45, 8). Uno per cui «il fragore dei tamburi diventi l’annuncio della Legge» (quarto Editto su Roccia di Asoka) e che «con la sua maestà mantenga sull’esterno sentiero dell’ordine il mondo tutto» (Nitisara di Kamandaki), un difensore e un maestro, un legislatore e un oracolo…
Anche Machiavelli, deposta la tragica penna sul calamaio, aspettava: «acciò che l’Italia dopo tanto tempo vegga un suo redentore». Un cavaliere, annunciava Petrarca «pensoso più d’altrui che di se stesso»: sembra poco, no è un’enormità. Léon Bloy, tra gli irrespirabili cannoneggiamenti del 1916, aspettava Qualcuno che sarebbe dovuto venire inaspettato da un Estero inimmaginabile, uno che sarebbe stato il Portento personificato. Il lemma visionario lo definiva meglio in questa formula: «un riflesso della Gloria in una cloaca». Sarà così, se sarà.
Se aspetto anch'io qualcuno fuori dei momenti e dei giorni di inutile disperazione, è per fare qualcosa che non sia un fare, perché ogni fare pubblico è ormai indicibilmente satanico: tutto quel che si fa, anche il buono, finisce nello stesso pozzo avvelenato, da cui esce un vapore che ci fa ciondolare ubriachi di miasma, istupiditi. In profondo, è un’attesa da lager: ma è lì che siamo, in un lager, tanto gli oppressi dalla libertà come gli oppressi dall'oppressione. Da Brest a Vladivostok un Liberatore avrebbe un lavoro infinito da compiere per liberare.
***
Qualcuno che non sia inquadrabile da una telecamera. Nel tentativo di catturarne l’immagine, le telecamere dovrebbero incendiarsi. Per riscattare l'umanità bisogna sterminare tutto quel che condanna l'uomo a non essere che la propria ombra, immagine trasmissibile e impacchettabile, gelatina del Nulla. Bisogna abbandonare il teleschermo alle sole canaglie, alle nullità a cui non importa di rappresentare il Nulla: dall'apparire in quel luogo li si riconoscerà. L’uomo probo, l'uomo pio conserva per sé l'immagine che sposta l'aria, santuario dell'Abitatore ignoto: un certo grado di iconofobia è necessario alla purezza morale. Siamo in una pattumiera terrificante di immagini in movimento: le peggiori sono quelle che stanno lì, davanti a un tavolo, e parlano.
Dante chiamava il suo Atteso veltro: per esprimere la sublimità del suo concetto ha assunto l'immagine di un cane; il veltro dantesco e una divinità cinocefala. Infatti, un redentore d'uomini come può avere l'immagine disonorata dell'uomo?
Ci precipiteremmo fuori, nelle strade dove si ammucchierebbero questi ignobili attrezzi della nostra fine, automobili, televisori, calcolatori diventati repentinamente oggetti di illuminato disgusto, per andare dietro a uno che facesse fondere tutte le manette che portiamo attaccate alle tempie, avesse pure la testa di un cane. E tagliasse pure le teste delle guide false, delle guide criminali, dei carismatici usciti dal sottosuolo, di quelli che accendono, nei bambini messi in riga e in uniforme, nelle donne e nei religioso l'istinto omicida, la brama di estendere il deserto, di assassinare portatori di un passaporto. Ego repletus sum fortitudine spiritus Domini, il Veltro lo dice a se stesso, nell’ombra, non davanti al cameraman.
***
Non potrà essere la politica a farlo, e neppure, se sarà quel che deve essere, a disfarlo. La politica non genera bodhisattvas, né veltri, né redentori. La nostra appassionante sventura vuole che non generi neppure più dei politici. Ne sforna ancora, per antica abitudine, la polis anglo-americana, dove la funzione pubblica non è dissolvente, ma formatrice per chiunque la eserciti: nel resto del mondo siamo alle canaglie, ai mediocri, a qualche isolato impotente, ai funzionari di partito unico, ai dominatori di lugubri apparati stratocratici, ai paranoici e agli idrofobi.
L’uomo che ci vuole al momento giusto ha fatto la sua ultima apparizione nel 1958. In realtà la politica è un mestiere perduto, perché serve le modificazioni della Tecnica e va dietro alla Tecnica, che impugna la frusta sadica dell’Economia, come l’alcolista va dietro all’immagine della bottiglia che ha nascosto nell’armadio. Vorrei vederne uscire delle strutture ossee intellettuali e morali davanti a cui si arretrasse con rispetto e timore: ma già, allora, sconfineremmo nello spirto gentil che arriva vestito di ferro e fa le rose uscire dal mistero delle sue mani.
Mi conforta un pensiero di Tocqueville: «Ci sono momenti in cui il mondo somiglia a uno dei nostri teatri prima che si levi il sipario. Si sa che si sta per assistere ad un nuovo spettacolo. Si sentono i preparativi in scena; quasi tocchiamo gli attori, ma senza vederli, e ignoriamo che cosa si rappresenterà». Può darsi che la recita a cui stiamo per assistere sia lo stesso teatro che salta in aria insieme agli attori e al pubblico: tuttavia è bello che l’attesa di qualche nuovo e prodigioso evento ci divori.
Siamo qua, patriai tempore iniquo, né verrà Cesare a sciogliere, con la sua magica forza di Megalurgo, i nodi, una volta per tutte; immersi in una oscena farsa non osiamo fiatare, perché il diritto ci garantisce la parola, il crimine sghignazzante nell’ombra ce lo annulla, come il pugno del marinaio che turò la bocca alla Costituente russa per ordine di Lenin, che non era né Cesare né messia, ma un capo di fanatici in cui era agonizzante o spinta del tutto la legge morale.
Tuttavia aspettare qualcuno che sia in assoluto altro, uno Straniero, un Esiliato che abbia in comune con noi soltanto la forma umana, o neppure quella: la parola soltanto, la parola davanti a cui niente resiste, e la mano, ma guaritrice, esercitata a guarire toccando, è una interessante vendetta, un’ombra, se non la carne, di un rimedio, un modo per attenuare il dolore della piaga civile, per consolare il gemito insistente del cuore indecentemente oltraggiato.
Così ogni mattino mi dico: dovrà pur venire qualcuno, forse oggi stesso lo sapremo, scoprendo qualcosa di cambiato in una delle solite facce che s’incontrano, e venendo disperderà con un soffio, prima di ogni altra cosa, questa verminaia terra di poteri senza legge che ci intortiglia. E che si muoia aspettando, davanti al sipario che non si alza, mentre le ore passano: morire aspettando un redentore che non viene è un migliore morire che vivere senza averne neppure l’idea, il desiderio, la speranza.
È vero che aspettare una salvezza esteriore non è ortodossamente filosofico; ma è raro che, nelle tremende ore di questo transito tra i viventi, vita, morte, amore e filosofia non viaggino clamorosamente sconnesse. Forse il momento più felice della vita di Cristo fu quello in cui una prostituta si mise a ungerlo con begli unguenti. Aspettare è un unguento, e il lampo che ci abbaglia misteriosamente sostiene.
Per leggere il Messale Romano (Silvano Birboni)
Un nuovo commento a quattro mani uscito dalla penna di Rinaldo Falsini e di Angelo Lameri offre ancora l’occasione di ripercorrere la storia e il contenuto dottrinale e rituale dei riti della liturgia. Una lettura guidata, completa e aggiornata, che cerca di individuare la mens che sta dietro alle rubriche e alle ultime modifiche del Messale per favorire celebrazioni eucaristiche corrette e pastoralmente efficaci.
Una nuova domanda di etica per frenare il neoliberalismo (Giannino Piana)
Una nuova domanda di etica
per frenare il neoliberalismo
di Giannino Piana
Sono tante le vicende che, in questi ultimi anni in Italia (ma non soltanto), hanno reso evidente l’esistenza di una profonda crisi del capitalismo con effetti devastanti per l’intera comunità: dai casi Cirio e Parmalat fino a quello americano della Enror (e l’elenco potrebbe continuare) siamo di fronte a disastrosi fallimenti, che obbligano a riflettere seriamente sulle cause che li hanno provocati e sulla necessità di individuare in quali nuove direzioni camminare. A farne le spese sono infatti, in larga misura, lavoratori dipendenti (operai in particolare), che vedono improvvisamente messo in pericolo il loro posto di lavoro, e piccoli risparmiatori, ai quali viene sottratta una fonte (spesso non secondaria) di sostentamento.
In molti casi a determinare tali situazioni è la spregiudicatezza di singoli imprenditori, guidati da una sete irrefrenabile di guadagno e disposti a tutto pur di riuscire a emergere sul mercato. L’assenza di scrupoli morali e l’atteggiamento predatorio sono le ragioni di comportamenti (non infrequenti) che minano la credibilità del mondo imprenditoriale, non favorendo il reimpiego dei capitali e la stabilità lavorativa.
Ma, al di là dei comportamenti soggettivi, il problema assume contorni più vasti, che chiamano in causa il sistema in quanto tale e che reclamano soluzioni di portata più generale. Sussistono, infatti, risvolti strutturali, che impongono un ripensamento dell’economia in un orizzonte più ampio di quello della semplice ricerca del profitto; che esigono, in altre parole, un allargamento della riflessione ad altri parametri, che rivestono un’importanza sempre maggiore per il buon funzionamento dello stesso sistema economico. Del resto già nel 1988 Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, sosteneva che «una globalizzazione che non consideri parametri come l’opportunità sociale, l’analfabetismo, l’aspettativa di vita, la salute, può solo creare problemi che non possono essere attribuiti alla globalizzazione in sé, ma alle politiche con cui essa si è coniugata». E’ questa la ragione per cui, a partire dagli anni ‘90, la crescita di un Paese non viene più valutata sulla sola base del Pil, ma con riferimento a un indice umano più globale, che tiene conto anche di fattori legati alla qualità della vita. Ed è per questo che le aziende devono andare oltre il puro bilancio finanziario e tendere alla definizione di un bilancio di sostenibilità, non solo ambientale ma anche (e soprattutto) umana.
Ciò che viene emergendo è dunque una rinascita, all’interno dell’economia, di domanda etica per ragioni anzitutto economiche, per correggere cioè i difetti, sempre più evidenti, di un mercato senza regole. Non mancano anche oggi coloro che sollevano (anche se in misura più limitata che per il passato) obiezioni riguardanti la difficoltà oggettiva di conciliare la finalità di lucro con altri scopi: si tratterebbe - secondo costoro - di un vero conflitto, in quanto l’attenzione ai fini sociali (e il loro effettivo perseguimento) porterebbe, inevitabilmente, a distruggere ricchezza. E questo, a maggior ragione, in un contesto di globalizzazione, dove la concorrenzialità allargata rende necessario, se si vuole rimanere sul mercato, un livello sempre maggiore di competitività, e perciò un processo di costante innovazione tecnologica, i cui costi vanno conteggiati nell’ambito del bilancio.
Per quanto non sottovalutabili, tali obiezioni non sono tuttavia incontestabili, soprattutto se si considera che l’economia non può limitarsi oggi - ce lo ricordano gli studiosi più seri - a valutare i risultati in base ai parametri tradizionali - livello di produttività raggiunto ed entità del profitto conseguito - ma deve introdurre altre variabili, quali la protezione dell’ambiente, la stabilità del lavoro e, in un contesto mondiale come l’attuale, la ricerca di nuovi equilibri tra Nord e Sud del mondo. L’appello all’etica è dunque tutt’altro che superfluo: essa è infatti necessaria per ristabilire una corretta mediazione tra efficienza produttiva e solidarietà sociale. E forse utile ricordare, in proposito, un’esperienza paradigmatica che ha avuto luogo nel nostro Paese, quella di Adriano Olivetti, che è riuscito a dar vita, sia pure in tempi diversi, a un sistema in cui ai risultati finanziari si è congiunto lo sforzo di costruire una comunità umana in un contesto ambientale sano. Non può essere proprio questo modello un importante riferimento per restituire all’economia la capacità di perseguire il fine che le appartiene, quello di essere cioè al servizio della vera promozione umana?
L’invidia (Luciano Manicardi)
di Luciano Manicardi

Tra i vizi capitali un posto particolare occupa l’invidia. La tradizione cristiana, fondandosi sul testo di Sap 2,24: “per l’invidia del diavolo la morte entrò nel mondo”, ne colse l’estrema pericolosità. Il primo atto di invidia, del diavolo nei confronti dell’uomo, ebbe effetti devastanti, e si rivelò contagioso: l’uomo, da invidiato divenne invidioso e la storia biblica è piena di casi di invidia e di figure di invidiosi.
A passo di danza contro la rassegnazione (g.f.)
(g.f.)

«Cerchiamo di cogliere i segni di novità che il Vangelo introduce nella trama del quotidiano»