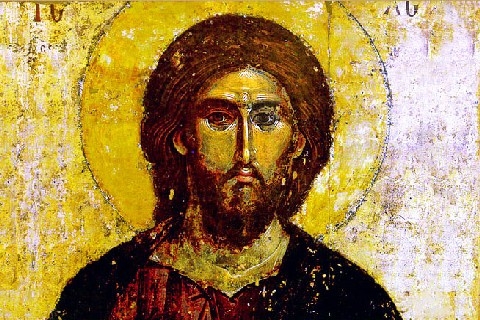Quando usiamo il termine «Dio» bisogna sempre chiedersi a quali immagini facciamo riferimento. Ad una proiezione – che abbiamo interiorizzato – della figura paterna? All’Essere perfettissimo? Al motore immobile? All’essere parminedeo, uno, eterno, immutabile?
Alla causa prima che da l’avvio al funzionamento dell’universo e poi si ritira da esso? All’intelligenza creatrice? Al «tappabuchi», usato per colmare le nostre domande che restano ancora senza risposta? Al distributore di miracoli, accessibile attraverso suppliche, lumini e quant’altro? Al Dio astratto e lontano dei teosofi e degli illuministi? Ad un’ipotesi dimostrabile more geometrico? All’oppio dei popoli, inventato dalle caste sacerdotali e dai detentori del potere politico ed economico al fine di conservare i propri privilegi? Al fondamento della morale borghese o della religione civile? Al cadavere putrefatto profetizzato dall’uomo folle di Nietzsche nel famoso aforisma 125 di Aurora? Al Dio della teologia femminista – rifiutato in quanto produzione del patriarcalismo, ma recuperato nel tentativo di raccogliere gli arcaici significati di una Dea Madre o della Gaia Terra? Al Dio degli eserciti – a cui anche la bibbia fa riferimento – pronto a marciare alla testa delle proprie armate poiché si è certi che Gott mit uns? Ad un processo necessario nell’evoluzione della civiltà umana, ma ormai diventato obsoleto di fronte ai risultati raggiunti dalla filosofia dello spirito, dalla scienza e dalla tecnica? Al giudice implacabile, pronto a condannare le creature al loro minimo errore? Al Sommo Bene? Al Dio misericordioso e buono? Al Padre di Gesù Cristo? Al Dio dei mistici e dei poeti?
«Dio» diventa di volta in volta il liberatore ed il conservatore, il radicale ed il reazionario, il colpevole e l’innocente, il giudice e la vittima, il lontano ed il vicino, un concetto astratto e l’amico, un sovrano magnanimo oppure dispotico, il debole ed il forte, l’onnipotente e colui che rinuncia alla propria potenza attraverso un ritrarsi dal mondo… E ci sembra che sia possibile tirare da ogni parte questa coperta per far in modo che ogni nostra idea abbia un sufficiente fondamento.
Il rischio è quello di creare un continuo corto circuito, sottacendo quale di queste immagini stiamo usando. Ed usando sempre l’immagine che al momento più ci aggrada, che maggiormente ci sembra rispondere ai nostri immediati bisogni. (Salvo poi non riuscire più a trovare risposte di fronte ad alcune domande difficili).
Non bisogna illudersi dicendo che in fondo «Dio» possa essere la somma di molte di queste nostre immagini e anche qualcos’altro. O, viceversa, ripetere che Dio è totalmente altro (ganz andere) per cui ogni nostro linguaggio umano, ogni immagine che usiamo non è capace di avvicinarsi ad esprimere qualcosa di valido riguardo a Dio. Entrambe queste posizioni rischiano di essere delle illusorie scorciatoie che possono, al massimo, portare a vagare intorno alle radure dell’essere di cui parlava Heidegger.
C’è chi ha proposto di non usare più per un certo tempo il termine «Dio», divenuto ormai troppo ambiguo e controproducente nel linguaggio umano. In questo caso il silenzio opererebbe un processo di purificazione, una catarsi linguistica. E c’è chi se la prende con il nostro tempo diventato ormai troppo complicato per vivere una fede semplice. Si auspica, allora, il ritorno ad un passato o si vive nella nostalgia di un’epoca che non esiste più.
Sottolineare il fatto che bisogna passare da un discorso su Dio al discorso con Dio non è ancora sufficiente. Passaggio importante per l’uomo di fede, soprattutto per chi, vivendo nella società della techné, si è abituato a descrivere il mondo, ma non a sperimentare la propria profonda relazione con il mondo stesso, poiché il rischio è quello di ridurre tutto ad una percezione individuale, personale del rapporto dell’uomo con Dio. Un altro modo di declinare gli odierni e onnipresenti: “secondo me”, “dal mio punto di vista”, “per la mia esperienza”, ecc. senza riuscire, in realtà a rendere comunicabile questa esperienza personale.
La società dell’immagine e dei mezzi di comunicazione sta producendo un continuo svilimento della parola. Nel ridondare delle informazioni la parola perde la sua forza, diventa ambigua, contraddittoria, sterile. Non conta quello che si è detto, sentito, letto perché immediatamente può essere smentito, contraddetto, svilito. Il linguaggio si fa sincopato – come quello dei messaggi sms o di certe canzoni rap. Si conosce il significato di sempre meno parole. Finiamo con l’usarne poche centinaia – per lo più in modo massivo, ripetendo frasi apprese alla televisione o parole che diventano dei tormentoni. Non ci sono più parole significative, che possono accompagnare a lungo la vita di una persona. Tutto viene consumato – bruciato – molto in fretta.
Anche il termine «Dio» non sfugge a questo processo di banalizzazione che oggi soffre il linguaggio umano. Ma non bisogna credere di poter trovare soluzioni saturando, ad esempio, le pagine di internet con continui riferimenti. Se Google offre un risultato di oltre 86 milioni di pagine per la ricerca del termine «Dio» (con «God» arriviamo a 581 milioni, «Dios», 73 milioni, ecc.) non dobbiamo dimenticare che otteniamo medesimi risultato per «Madonna» (cantante), mentre per la parola «sex» arriviamo a 747 milioni, a 279 con «basket», a 864 con «war» e a “soltanto” 308 milioni di pagine con la parola «peace» (ricerca fatta il 29 giugno 2008)
Di fronte alla spropositata quantità di informazione che i mass media ci offrono è urgente porre l’attenzione sulla qualità che deve contraddistinguere ogni discorso religioso e, soprattutto, ogni volta che si tira in ballo Dio. Il linguaggio religioso, senza dubbio, oggi si deve manifestare per il pudore con cui cerca di balbettare il nome di Dio. Il comandamento biblico a non nominarLo invano (Es. 20, 7) va intelligentemente coniugato all’interno della nostra società e della nostra cultura. Non è per il numero delle volte in cui affiora il termine «Dio» sulle nostre labbra che noi possiamo dirci credenti, ma nella misura in cui sappiamo esprimere la dimensione religiosa della nostra vita attraverso l’interpellanza etica rappresentata dall’altro (cfr. Mt. 7,21). Nella misura in cui sappiamo congiungere un atteggiamento mistico con una prassi, con un impegno che sa sporcarsi le mani nelle fatiche e nei dolori quotidiani. Un coinvolgimento che non s’illude delle facili compensazioni psicologiche date dalla filantropia, ma che sa misurarsi con l’urgenza della giustizia e della carità.
Forse può sembrare una sconfitta – soprattutto per quanti sposano l’idea di un cristianesimo identitario. Vale a dire per quanti ritengono di poter agire all’interno di questa società ponendosi in un rapporto di forza, di visibilità e di competizione. In realtà, per il cristiano c’è una chiave di lettura possibile – anche all’interno di questa società che è ancora in una ricerca affannosa dell’esperienza religiosa, ma che ha smarrito l’uso del termine «Dio». Oggi, forse, possiamo comprendere in una maniera maggiormente approfondita il significato della kenosi divina di cui parla Paolo nella lettera ai cristiani di Filippi (2,8). «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» (2,5). Forse, oggi, in questo tempo di fatto senza «Dio» possiamo incominciare a capire qualcosa dei sentimenti del Cristo nella sua esperienza di annichilimento divino.
Si è presi da un senso di smarrimento? Si tratta di una strada impercorribile, di un sentiero che necessariamente s’interrompe nella selva della conoscenza umana? Ci sembrano affermazioni che sottintendono la defaillance della ragione di fronte alla comprensibilità di Dio? Sono questioni superate, già a suo tempo poste dalla teologia radicale?…
Ma tutte queste sono domande legittime o solamente resistenze psicologiche dovute al fatto che non siamo disposti ad allontanarci dalle nostre immagini relative a «Dio»?
La bibbia pone come fondante l’esperienza dell’esodo. L’uscita del popolo ebraico dall’Egitto resta un ideale perenne. Un prototipo che si rinnova nel tempo e nell’esperienza. Non si tratta soltanto di lasciarsi dietro alle spalle gli idoli e le loro immagini, ma anche «le cipolle, i cocomeri, i meloni, i porri, l'aglio ed il pesce» (cfr Nm. 11, 5). Di fatto, abbiamo molte cose per restare radicati, nella nostalgia, all’esperienza trascorsa. Le molte immagini – mitiche – che non ci permettono di vivere a pieno l’assoluta novità dell’oggi. Si può continuare ad avere molte fantasie, ancorati alle nostre immagini ed ai nostri demoni.
Si tratta di capire come nella debolezza, nella fragilità, nella caducità dell'«erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno» e che tuttavia «neanche Salomone, con tutta la sua gloria» è in grado di eguagliare (cfr. Mt 6, 25-30), c’è la chiave per avvicinarsi a comprendere qualcosa di Dio. Cosa racchiude un giglio del campo? Che cosa ci può indicare un passero che vola nel cielo? Nulla?
Oltre ad un necessario pudore per non abusare nel nostro linguaggio del termine «Dio» bisogna, dunque, costantemente tenere presente a quale immagine di Dio si sta facendo riferimento. È lungo questo itinerario senza protezioni – un’esodo – che siamo chiamati a camminare.
Faustino Ferrrari