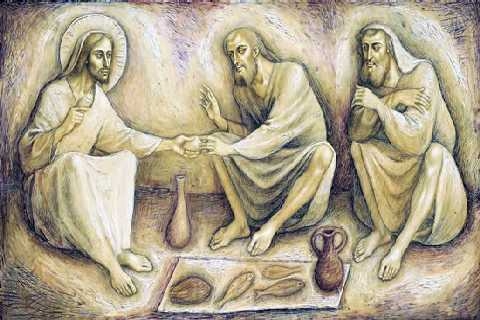oppure fluisce come historia salutis in actu dal cuore del popolo di Dio, nutrita dalla teologia, dalla spiritualità e dalla pastorale che il concilio ha indicato alla chiesa come vie maestre per il nostro tempo (cosa che chiamiamo liturgia inculturata)? La risposta al quesito, che è scontata in linea di principio, non lo è altrettanto a livello di pastorale liturgica (1).
1. Il magistero conciliare
Non si può cento dire che nella costituzione liturgica la problematica dell'inculturazione abbia avuto la parte del leone. Quattro scarni numeri si occupano del problema, lasciando al mondo gesuitico l'onere di introdurlo nella teologia e nella prassi (2). Il testo appare insufficiente nella 'lettera' - non poteva che essere così - ma risulta sostanzioso e carico di potenzialità nello 'spirito'.
SC 37 afferma la determinazione della chiesa a favorire le qualità e le doti dei vari popoli, non imponendo nella liturgia una rigida uniformità. La liturgia si trova ad essere luogo teologico di verifica della maternità accogliente della chiesa nei confronti delle individualità culturali dei suoi figli. L'unica condizione per abbracciare nel culto cristiano elementi culturali estranei è l'assenza di legami con errori e superstizioni e l'armonia con lo spirito della liturgia. La dichiarazione segna una svolta epocale se raffrontata alle minacce di scomunica intimate dal Messale tridentino a chi avesse osato minimamente alterare testi e riti liturgici (3).
SC 38 definisce l'esigenza di salvaguardare la sostanziale unità del rito romano e contemporaneamente di aprirsi alle legittime diversità con opportuni adattamenti. Infine, SC 39 specifica le competenze per gli adattamenti, riservati all’autorità ecclesiastica e non lasciati all'arbitrio di singole persone o comunità; e il n. 40 delinea il percorso dell'adattamento, frutto di sinergia tra organismi centrali e autorità locali, maturato dopo preliminari sperimentazioni condotte da esperti (4).
2. Come declinare l'adattamento?
Da queste linee ispirative sono derivate forme minimaliste di adattamento. La più elementare è l'accomodatio. Essa non implica un confronto culturale, poiché applica le diverse modalità celebrative previste dagli stessi rituali; è operata dal presidente o concordata con i ministri e mira alla fruttuosa partecipazione rispondendo al bisogno di una liturgia che sia adeguata alla cultura dei singoli popoli (5). Alle possibilità offerte, non corrispondono attuazioni confortanti: in Italia si riscontra una prolungata fase di stanchezza ripetitiva, seguita agli anni immediatamente successivi al concilio, caratterizzati da autentiche abbuffate di novità. Molti presidenti o non conoscono o non utilizzano neppure una semplice e legittima forma di varietà rituale, abituati ad una 'pigrizia' celebrativa sulle cui cause sarebbe bene riflettere.
Una seconda forma di adattamento è l'acculturatio (o optatio) e investe un piano antropologico-culturale. Consiste nel contatto o nel cosiddetto 'prestito' culturale, ovvero nell'«incontro fra due culture», alla ricerca di una comunicazione improntata su relazioni «di mutuo rispetto e tolleranza» (6). In questo 'rapporto aperto' la chiesa esercita un «ministero di riconciliazione delle culture a livello mondiale» (7). Posta la cosa in questi termini, l'acculturazione può sembrare assai simile all'inculturazione; ma in realtà la prima è premessa della seconda. L'acculturazione assume concretamente differenti modalità: accettazione, adattamento o reazione (8). Le tre forme liturgiche conseguenti sono l’'incorporazione', la 'sostituzione' e l’'illustrazione' del rito. All'apparenza operazione semplice e priva di difficoltà, l'acculturazione non è tuttavia scevra di equivoci: a lungo andare, l'esperienza culturale e cultuale, dopo aver siglato un armistizio, si limitano a camminare l'una accanto all'altra parallelamente, senza incontrarsi mai, senza una «fusione di orizzonti». Il rischio, a livello soggettivo, è di generare psicologie a compartimenti stagni incomunicabili; a livello oggettivo, è che il compromesso continuamente stipulato tra culto e cultura produca un rito nel quale il 'genio' del culto cristiano risulta modificato dalla coabitazione con elementi estranei, dato che con essi non è stata ricercata interiore armonia. Il risultato finale è una sorta di riduzionismo, non tanto del rito romano, quanto dell'evento cristiano e del suo cuore - il mistero pasquale - in nome dell'esotismo e del sincretismo (9).
3. Si fa presto a dire inculturazione!
È ancora possibile oggi parlare di inculturazione, stadio avanzato dell'adattamento? Qualsiasi fede - per la sua stessa sopravvivenza - deve tradursi in modi di essere, di pensare e di vivere, ovvero in cultura. La fede cristiana è debitrice alla cultura dei suoi canali comunicativi, ma non per questo può lasciarsi fagocitare in nome di un pluralismo o di un sincretismo di marca New Age. La fede è creditrice nei confronti della cultura per il fatto che le fornisce un’'anima', grazie alla sua trascendentale capacità di rendere assoluto ciò che è culturalmente relativo. Ma il colloquio tra fede e cultura, certamente necessario e arricchente, è anche problematico. In ambito liturgico, come operare un adattamento rispettoso contemporaneamente del mistero divino e del fattore antropologico? Uno dei maggiori esperti del settore, alcuni anni or sono sinteticamente rispondeva:
Mentre l'acculturazione, con l'assunzione di nuovi elementi culturali, induce un cambiamento o modifica del genio romano, l'inculturazione produce un cambiamento nella cultura tramite l'inserimento in essa del messaggio cristiano. Il processo di inculturazione è una forma di conversione alla fede, di una metànoia dei riti pre-cristiani (10).
Ho l'impressione che l'ineccepibilità formale di questa soluzione nasconda una logica riduttiva e parziale: quella di una dialettica tra due opposti estremismi. Il primo modello, cioè l'acculturazione, si risolverebbe in un cedimento della liturgia cristiana alle diverse culture, mentre il secondo, cioè l'inculturazione, sancirebbe la definitiva capitolazione delle culture di fronte alla liturgia. Ritengo per lo meno discutibile che il rapporto tra due realtà così significative e necessariamente intercomunicanti sia fondato su una conflittualità, dalla quale una delle due deve uscire vittoriosa e l'altra sconfitta. L'impostazione che riteniamo corretta non sta in una diminuzione dell'una o dell'altra, o addirittura in una sorta di aut aut tra fede e cultura, ma in un et et 'partecipativo', in una positiva composizione dialogico-dialettica, che consenta un approccio non equivoco tra vangelo e culture".
Non esiste una fede cristiana a-culturale o pre-culturale: esiste solo una fede già 'accasata' in un éthos. La cultura non è mai stata inerte di fronte al vangelo e il vangelo non ha mai rinnegato il fascino della cultura. L'inculturazione esprime il perenne divenire della chiesa, nella fedeltà alle sue origini e nella docilità allo Spirito, e l'incessante bisogno della fede di trovare originali ed inedite espressioni. Più che ad un atto puntuale l'inculturazione è rapportabile ad un processo dinamico, ad un modo di essere permanente. Ed è per una ragione teologica, prima che funzionalista, che la teologia e la pastorale si sono abbondantemente occupate di inculturazione nell'ultimo decennio.
4.A che punto siamo in Italia?
Nella mens del legislatore ufficiale il problema dell'inculturazione si pone essenzialmente per le aree geografiche lontane da Roma. Le comuni radici cristiane dell'Europa, richiamate costantemente da Giovanni Paolo II e da alcuni ritenute il fondamento dell'uniformità, non hanno tuttavia mai prodotto una unica e monolitica forma di esperienza cristiana dagli Urali all'Atlantico. La chiesa d'Europa è un concerto di chiese nazionali e di chiese locali dotate di un animus unico e irripetibile. Se questo è visibile in grandi stati che possiedono una secolare storia di unità nazionale e di uniformità culturale, è ancor più evidente per l'Italia, la cui unità politica è assai recente e la cui unità culturale è di là da venire. Tale condizione fa invocare una liturgia romana inculturata dalla chiesa italiana per l'Italia, attenta a sensibilità e a spiritualità specifiche, segnate da santi e da personaggi, talvolta viventi, che hanno tracciato un solco; impostata su una maggiore sensibilità biblica instauratasi in Italia; mossa da uno stile caritativo che ha connotato il passato e il presente; accogliente di una evoluzione degli stili di vita che non lascia indenne nessuno.
Negli ultimi anni la chiesa italiana si è sforzata di produrre libri liturgici non solo tradotti, ma inculturati (i due esempi migliori sono il Benedizionale e la seconda edizione del Messale), ma ha dovuto affrontare ostacoli al suo esterno e al suo interno. Il vero nemico di una liturgia inculturata emerge quando la povertà di fede mortifica l'arte di celebrare, lasciando spazio a un rito monotono e ripetitivo che logora presidenti e comunità. Il maggiore talento inculturativo, allora, non è affidato ai traduttori e ai revisori, ma a quella schiera innumerevole di pastori e fedeli che accolgono la liturgia, con i suoi riti e le sue espressioni, come un prezioso spartito, muto fino a quando autentici artisti elevano a Dio - grazie ad esso - uno splendido inno di benedizione e di lode.
Samuele Riva
Note
1. La brevità che ci è qui richiesta impone di soprassedere ad un breve excursus storico, che consiglieremmo tuttavia a coloro che sono interessati all'argomento: lo Jedin sul versante storico e il Cattaneo sul versante storico-liturgico offrono abbondante documentazione.
2. P. ARRUPE, Introduzione, in G. GENERO (ed.). Inculturazione della fede. Saggi interdisciplinari, Dehoniane, Napoli 1981,9-10.
3. Cfr. la parte finale del decreto Quo primum che promulgava il messale di Pio V.
4. Il problema nel concilio e nel post-concilio è affrontato da vari autori in R. FISICHELLA (ed.), Il Concilio Vaticano II. Ricezione e attualità alla luce del Giubileo, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2000,209-275 e 585-592.
5. A. CHUPUNGCO, Adattamento, in D. SARTORE - A.M. TRIACCA (edd.), Nuovo Dizionario di Liturgia, Paoline, Roma 1984, 2.
6 A. SHORTER, Toward a Theology of Inculturation, London 1988,6-8; una lettura sintetica dell'opera viene offerta da L. LAGO, «Toward a Theology of inculturation». Una proposta teologica, in Credere Oggi 115(1/2000)51-64.
7 A. SHORTER, Toward a Theology of Inculturation, cit.
8. M. DHAVAMONY, Inculturazione. Riflessioni sistematiche di antropologia sociale e di teologia cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2000, 39-40.
9. La teologia non manca di offrire criteri certi per l'adattamento liturgico. Si tratta di «ritradurre l'intenzionalità della celebrazione cristiana nel contesto culturale dato; l'adattamento non procede concettualmente da rito a rito, bensì ritraduce l'intenzione rituale presente nel complesso celebrativo ricevuto dalla tradizione in un diverso sistema simbolico»: così F.G. BRAMBILLA, Ermeneutica teologica dell'adattamento liturgico, in AA.VV., Liturgia e adattamento. Dimensioni culturali e teologico-pastorali. Atti della XVIII settimana di studio dell'Associazione Professori di Liturgia (Erice, 27 agosto - 1 settembre 1989), C.L.V. - Edizioni liturgiche, Roma 1990,79.
10. CHUPUNGCO, Adattamento, cit., 14.
11. Siamo confortati in questa persuasione da una letteratura di tutto rispetto, che abbiamo raccolto nella tesi di licenza: S. RIVA, Itinera fidelitatis sunt semper et necessario itinera creativitatis. L'inculturazione e la creatività come criteri di fedeltà allo spirito della costituzione conciliare "Sacrosanctum concilium” discussa presso l'istituto di liturgia pastorale «S. Giustina» in Padova nell'anno accademico 1996/97.
12.SHORTER, Toward a Theology of inculturation, cit., 11. Potremmo dire che, se ben intesa, l'inculturazione non può essere considerata un semplice adattamento, ma una vera e propria incarnazione e una nuova creazione; in questo senso non può mai essere disgiunta dalla «sapiente creatività». Cfr CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, La liturgia romana e l'inculturazione. Quarta istruzione per una corretta applicazione dello costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia (nn. 37-40), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994.
«La Chiesa, quando non è in questione la fede o il bene comune generale, non intende imporre, neppure nella liturgia, una rigida
uniformità; rispetta anzi e favorisce le qualità e le doti di animo delle varie razze e dei vari popoli. Tutto ciò poi che nel costume dei popoli non è indissolubilmente legato a superstizioni o ad errori, essa lo considera con benevolenza e, se possibile, lo conserva inalterato, e a volte lo ammette perfino nella liturgia, purché possa armonizzarsi con il vero e autentico spirito liturgico. Salva la sostanziale unità del rito romano, anche nella revisione dei libri liturgici si lasci posto alle legittime diversità e ai legittimi adattamenti ai vari gruppi etnici, regioni, popoli, soprattutto nelle missioni; e sarà bene tener opportunamente presente questo principio nella struttura dei riti e nell'ordinamento delle rubriche» (Sacrosanctum concilium 37.38).