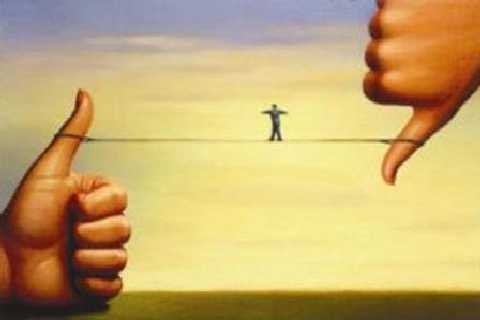Padova: un'iniziativa della "Fondazione Lanza" e di altri organismi
Un ethos in cambiamento?
Per rilanciare la dimensione etica della convivenza, è necessario capire come mutano i comportamenti e i valori nella chiesa e nella società. Guardiamo prima in ambito ecclesiale.
Sono tre gli interrogativi alla base di un nuovo progetto avviato dalla Fondazione Lanza di Padova in stretta collaborazione con la Pastorale sociale, il Centro Toniolo e la scuola di Formazione all'impegno sociale e politico (Fisp) della diocesi di Padova: come ritessere i legami sociali in un contesto che sembra talvolta disconnesso? Come ritrovare la capacità di costruire assieme il bene comune? Come riattivare quella capacità di dialogo costruttivo tra posizioni differenti che costituisce l'elemento portante del vivere civile?
Domande di forte attualità che interpellano trasversalmente mondo ecclesiale e mondo civile su cui la Fondazione Lanza ha sentito la necessità di impegnarsi in un nuovo progetto dedicato all'etica civile, che trova una felice coincidenza nei festeggiamenti (e conseguenti dibattiti) sui 150 anni dell'unità d'Italia e una sua improcrastinabilità di fronte alla richiesta proveniente da diverse fasce del nostro paese - non solo sociali e politiche, ma anche culturali ed ecclesiali - che vivono con crescente disagio le tensioni che stanno lacerando il tessuto civile della nazione e chiedono a gran voce un nuovo senso civico. «Si tratta quindi - commenta il referente del progetto, Simone Morandini - di comprendere come individuare le linee di questo nuovo ethos in un contesto di accentuato pluralismo, che non può più presupporre un'omogeneità culturale della società civile, ma neppure rinunciare all'attivazione di una comunicazione tra le sue diverse componenti, quasi dovessimo ormai considerarci "stranieri morali"».
Un cambiamento su tre fronti
Un percorso di studio, ricerca, riflessione che, proprio per l'attualità e l'urgenza, ha coinvolto realtà di formazione importanti e significative. «Se ogni tematica etica - prosegue Morandini - si caratterizza per una componente educativa, a maggior ragione ciò vale per questo percorso, che interessa valori e comportamenti di grande rilievo per lo spazio pubblico. In questa prospettiva, in alcuni momenti si punterà al coinvolgimento di alcuni giovani, interessati ad acquisire competenze per una valorizzazione della dimensione etica nelle rispettive aree di competenza. La collaborazione di Fisp, Centro Toniolo e Pastorale sociale esprime proprio la volontà di affiancare una significativa dimensione operativa e pratica a quella ricerca etica che fin dal suo nascere ha caratterizzato la Fondazione Lanza».
Il progetto "etica civile" si presenta trasversale e investe anche gli altri ambiti di lavoro della Fondazione Lanza: etica ambientale, bioetica, etica in riferimento alla filosofia e alla teologia. Una trasversalità che si traduce in appuntamenti di approfondimento per il pubblico e in altri più seminariali, sviluppati, nell'arco dei primi due anni, come un vero e proprio percorso che prende il via dalla ricognizione dei cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni nell'ethos, sia in ambito ecclesiale che in quello civile, e successivamente si prefigge di disegnare alcune linee di rinnovata etica civile, attenta a valorizzare la responsabilità personale, ma anche la qualità della relazionalità, interrogando, da un lato, gli ambiti di vita pubblica e, dall'altro, temi più specifici: la rilevanza di comportamenti orientati al bene comune in riferimento alle problematiche ambientali; il rapporto con la realtà politica ed economica; i temi bioetici alla luce della Costituzione italiana.
Il primo passo è quindi analizzare la situazione e le motivazioni: solo partendo dallo stato dell'arte in ambito di etica civile sarà possibile avviare la ricostruzione - su basi solide e condivise - delle ragioni e della grammatica di una buona convivenza, rilanciando l'idea di una cittadinanza responsabile.
Il primo appuntamento con il monitoraggio della situazione, rispondendo alla domanda Un ethos in cambiamento? Per una nuova etica civile, nello spazio ecclesiastico, ha visto i contributi del pastoralista Luca Bressan e del moralista Pierdavide Guenzi. Successivamente, venerdì 13 maggio, la domanda verrà declinata nello spazio civile con le voci del sociologo Italo De Sandre e del filosofo Antonio Da Re.
Leggendo in forma sociologica le trasformazioni della chiesa, Luca Bressan individua fondamentalmente tre cambiamenti in atto, rispettivamente sul piano organizzativo, culturale e teologico.
L'aspetto organizzativo è quello che maggiormente sta modificando il tessuto ecclesiale in quanto si evidenziano delle mutazioni che coinvolgono l'ossatura stessa della chiesa, la sua struttura. In particolare, negli ultimi anni in Italia si sono registrate alcune evidenze: una progressiva diminuzione del clero autoctono, una scelta vocazionale più orientata al mondo religioso e un progressivo aumento di preti stranieri, seppur con forti distinzioni geografiche (la presenza di preti stranieri integrati nelle chiese locali è particolarmente accentuata in centro Italia, mentre il Nord-est è ancora il capofila come densità di clero).
Questi dati oggettivi hanno alcune conseguenze pratiche che rilevano profonde mutazioni nell'organizzazione ecclesiale: sono state avviate, per esempio, le unità pastorali e sono nate altre forme organizzative come risposta a nuovi "consumi e bisogni" religiosi. La pratica religiosa, infatti, contrariamente a quanto si può pensare, non denuncia una flessione, ma registra una forte diversificazione nella modalità in cui si esprime.
Un secondo fronte di cambiamento, Luca Bressan lo individua sul piano culturale, là dove invece di parlare di secolarizzazione, il pastoralista preferisce utilizzare il termine "de-secolarizzazione", specificando in questo modo come sia il legame religioso ad aver vissuto una "secolarizzazione interna": a dimostrarlo sono in particolare alcune indagini riferite per esempio a "cosa viene considerato peccato", che fanno emergere «una pratica dell'individualizzazione e della contrattazione con la tradizione a cui si appartiene». In alcuni casi, commenta Bressan, «lo stress dei preti sembra dovuto proprio allo sforzo impiegato nel tentativo di rimotivare alcuni comportamenti. La chiesa sembra avere una tradizione che non sta al passo con i tempi e alcune situazioni "tipo" ci interrogano».
Un terzo fronte di mutamento riguarda l'ambito teologico. Analizzando alcuni documenti, da Evangelizzazione e sacramenti del 1973, al documento postsinodale del 1985, al documento La Chiesa in Italia dopo Loreto (1986), si coglie una chiesa che oscilla tra posizioni rigide e di cambiamento, ma che fondamentalmente sembra faticare a ritrovarsi, a capire la cultura che le si presenta e a trovare una sua identità. «Una chiesa dunque - chiosa Luca Bressan - che deve crescere», che in alcuni casi ha paura e perciò «nomina il diverso come nemico».
Tre sfide con cui misurarsi
Di fronte a questo panorama che sfide si propongono alla chiesa italiana del 21° secolo e quali sono le "energie" e le potenzialità che può mettere in atto?
Luca Bressan individua tre sfide. La prima si pone in relazione alla perdita da parte della chiesa del principio di correlazione, ossia la capacità di riconoscere dentro la società dei luoghi antropologici che le permettano di annunziare il vangelo. «Principio che sta alla base della capacità del cristianesimo di incarnarsi nella società». Ciò significa oggi confrontarsi anche con i nuovi linguaggi e in particolare con la cultura digitale. Il rischio altrimenti è di passare da un cristianesimo "stile chiesa", ossia di popolo, a un cristianesimo "stile setta": «questo sarebbe un mutamento ecclesiale senza precedenti nella chiesa italiana».
La seconda e terza sfida chiedono una nuova elaborazione teologica perché registrano una deriva culturale che rischia di cambiare la rappresentazione del legame ecclesiale e di perdere la rappresentazione di "chiesa di popolo". Da un lato, si registra infatti «la necessità di rimotivare il compito che la chiesa italiana si è vista attribuire, di prendersi cura del legame sociale: si sta andando verso un cristianesimo più religioso e meno solidale». Dando il primato all'annuncio, la solidarietà rischia di essere estromessa dal legame ecclesiale. Dall'altro lato, è «in atto (anche in Europa) il mutamento del modo di immaginare la rappresentazione sociale del legame ecclesiale: si sta passando da un cristianesimo di trasmissione a uno di conversione, che esalta l'uomo, l'individuo».
L'etica di fronte al cambiamento
Sono sfide importanti di fronte alle quali la chiesa, per accompagnare il mutamento ecclesiale in atto, senza rinunciare ad essere una chiesa di popolo, può far leva su due principi preziosi: itineranza e contaminazione. Il principio di itineranza (colto soprattutto dai preti che vivono nel territorio, con la gente) vede un cristianesimo vissuto come esperienza di accoglienza, che riconosce la libertà dell'individuo, ma coglie e riconosce i segni minimi di fede, di interesse verso la memoria cristiana. È un atteggiamento molto diffuso tra i preti autoctoni, più difficile con gli stranieri, strutturati su modelli diversi.
La seconda "energia" disponibile è data dal principio di contaminazione secondo cui «il cristianesimo accetta di lasciarsi contaminare dalle forme culturali e religiose che intende abitare», in una logica di confronto alla pari.
Altrettanto, se non più complessa, appare la situazione letta sul fronte dei diversi modelli etici, analizzata da Pierdavide Guenzi, che ha proposto un articolato viaggio negli ultimi due secoli di storia teologica, con l'ausilio della letteratura (partendo dal Discorso sullo stato presente del costume italiano di Giacomo Leopardi del 1824 per arrivare alle Città invisibili di Italo Calvino del 1972) e attraversando la problematica etica nella declinazione postmoderna del dubbio sulla reale entità di ciò che è bene e ciò che è male; i quesiti posti dall'etica su base universale; e ancora il rilancio della legge naturale, senza dimenticare il principio evolutivo; la rischiosa vicinanza tra ecumenismo morale e sincretismo etico; l'unicità etica tradotta in un pluralismo linguistico, per arrivare a soffermarsi maggiormente sulla prospettiva della regola d'oro (Mt 7,12 e Lc 6,31) che propone il codice della prossimità umana, come nervatura di un ethos da tradurre là dove c'è povertà, isolamento, indifferenza, elaborando un codice dell'ospitalità.
Sara Melchiori
(da Settimana, n. 14, 2011)