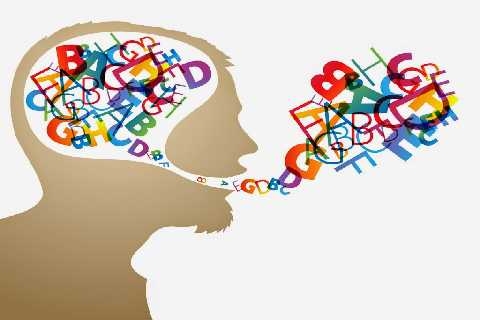Mentre sto scrivendo un elicottero dei carabinieri sta sorvolando la città – per controllare se nelle strade ci siano persone o movimentazioni. È così da diversi giorni. Siamo confinati nelle case, come durante uno stato d'assedio o un coprifuoco. Ma queste ultime sono misure dei tempi di guerra.
Ma siamo in guerra? A sentire certi ridondanti messaggi sembrerebbe proprio di sì. Combattere la battaglia decisiva… Comando strategico… Resisteremo e combatteremo ovunque, nelle case, nei luoghi di lavoro… Ci sacrifichiamo per un domani migliore… L'esercito in campo… Non è difficile ritrovare queste immagini – e tante altre simili – nei discorsi dei politici, nelle pagine dei quotidiani, sui social.
E non ci fa neppure molta specie. Da tempo ci siamo abituati al linguaggio violento, virulento e brutale dei social. In molti lo hanno adottato e ci navigano senza alcuna remora. Ma dobbiamo chiederci: è normale affrontare una malattia – un'epidemia – con il linguaggio militare? Infatti, non è in gioco soltanto una questione di termini usati, ma il linguaggio comporta ben altro: è l'espressione di una visione della realtà e della storia, di un approccio culturale, di una dimensione esistenziale.
Lo stato d'eccezione prodotto dall'epidemia del coronavirus, unito all'impiego del linguaggio militare, non può non causare allarme e preoccupazione. Alcuni segnali ci sono. C'è chi invoca i pieni poteri. Altri che auspicano l'attuazione di un colpo di stato… Non solo. È significativo che la produzione delle armi sia stata ritenuta indispensabile dal governo e che a tutt'oggi le fabbriche restino aperte e operative. Come la direttiva (poi rientrata) che dava ai militari e ai loro familiari priorità assoluta per eseguire il test del coronavirus.
Con tali premesse, uno stato d'eccezione potrebbe trasformarsi velocemente in uno stato permamente d'eccezione. Vale a dire, la fine di un regime democratico.
Aldilà di queste considerazioni, usare per la cura delle persone il linguaggio militare è da folli. Sottintende sì che la malattia è il nemico da sconfiggere, ma il portatore della malattia (il paziente infetto da coronavirus) corre il pericolo di non essere più una persona da curare, ma un corpo estraneo da combattere. Il trattamento non è veicolato soltanto dall'isolamento, ma dall'ostilità.
L'approccio militare è sempre nei termini del controllo e della repressione, esercitati in maniera antagonista. A livello etico ciò sottintende un'assoluta eteronomia, che si esplicita nel comando e nell'obbedienza. Attraverso un controllo continuo – l'onnipresente occhio del Grande Fratello.
Qual è il margine residuo di libertà?
Quest'epidemia, invece, rende evidente la necessità di una somma capacità d'autonomia – un'interiorizzazione delle norme tale da guidare il comportamento dei singoli nei termini della responsabilità (verso se stessi e verso il prossimo) e della partecipazione. I problemi che si stanno presentando – e che si stanno affrontando, secondo schemi militaristici, nei termini della punizione e della repressione – sono dovuti in gran parte allo scarso senso di responsabilità. Emerge così il fallimento educativo, l'odierna incapacità ad educare verso la vera autonomia personale. Si è preferito utilizzare una massiccia diffusione della videosorveglianza, sicuri che l'occhio del Grande Fratello fosse sufficiente a contenere il comportamento dei singoli.
Don Lorenzo Milani sognava una scuola capace ad educare i cittadini in modo tale che non ci fosse bisogno neppure dei vigili urbani. Sicuramente un'utopia educativa. Ma l'emergenza di questi giorni ci sta facendo toccare con mano quanto sia importante educarsi ad un senso di responsabilità personale e collettiva. Poiché non sono le armi a sconfiggere i virus e neppure la retorica di certi discorsi. Anche da uno stato d'eccezione «sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia» (Lettera a una professoressa).
La malattia, infine, può essere considerata soltanto nei termini della cura e della prevenzione. Una cura, per essere vera ed efficace, necessita di un linguaggio partecipativo, accogliente, affettivo, nonviolento. Ecco, sarebbe allora necessario coltivare un linguaggio della com-passione. Di quel sentire comune che sa prendersi a cuore l'altrui patire nella consapevolezza che l'esperienza che stiamo vivendo non riguarda soltanto alcuni singoli malcapitati, ma che facciamo tutti parte di una medesima realtà. E che insieme s'impara a vivere i dolori e le sofferenze, le gioie e le speranze.
Faustino Ferrari